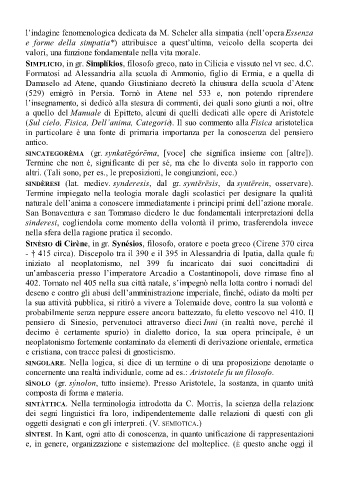Page 774 - Dizionario di Filosofia
P. 774
l’indagine fenomenologica dedicata da M. Scheler alla simpatia (nell’opera Essenza
e forme della simpatia*) attribuisce a quest’ultima, veicolo della scoperta dei
valori, una funzione fondamentale nella vita morale.
SIMPLICIO, in gr. Simplíkios, filosofo greco, nato in Cilicia e vissuto nel VI sec. d.C.
Formatosi ad Alessandria alla scuola di Ammonio, figlio di Ermia, e a quella di
Damaselo ad Atene, quando Giustiniano decretò la chiusura della scuola d’Atene
(529) emigrò in Persia. Tornò in Atene nel 533 e, non potendo riprendere
l’insegnamento, si dedicò alla stesura di commenti, dei quali sono giunti a noi, oltre
a quello del Manuale di Epitteto, alcuni di quelli dedicati alle opere di Aristotele
(Sul cielo, Fisica, Dell’anima, Categorie). Il suo commento alla Fisica aristotelica
in particolare è una fonte di primaria importanza per la conoscenza del pensiero
antico.
SINCATEGORÈMA (gr. synkatēgórēma, [voce] che significa insieme con [altre]).
Termine che non è, significante di per sé, ma che lo diventa solo in rapporto con
altri. (Tali sono, per es., le preposizioni, le congiunzioni, ecc.)
SINDÈRESI (lat. mediev. synderesis, dal gr. syntērēsis, da syntērein, osservare).
Termine impiegato nella teologia morale dagli scolastici per designare la qualità
naturale dell’anima a conoscere immediatamente i principi primi dell’azione morale.
San Bonaventura e san Tommaso diedero le due fondamentali interpretazioni della
sinderesi, cogliendola come momento della volontà il primo, trasferendola invece
nella sfera della ragione pratica il secondo.
SINÈSIO di Cirène, in gr. Synésios, filosofo, oratore e poeta greco (Cirene 370 circa
- † 415 circa). Discepolo tra il 390 e il 395 in Alessandria di Ipatia, dalla quale fu
iniziato al neoplatonismo, nel 399 fu incaricato dai suoi concittadini di
un’ambasceria presso l’imperatore Arcadio a Costantinopoli, dove rimase fino al
402. Tornato nel 405 nella sua città natale, s’impegnò nella lotta contro i nomadi del
deseno e contro gli abusi dell’amministrazione imperiale, finché, odiato da molti per
la sua attività pubblica, si ritirò a vivere a Tolemaide dove, contro la sua volontà e
probabilmente senza neppure essere ancora battezzato, fu eletto vescovo nel 410. Il
pensiero di Sinesio, pervenutoci attraverso dieci Inni (in realtà nove, perché il
decimo è certamente spurio) in dialetto dorico, la sua opera principale, è un
neoplatonismo fortemente contaminato da elementi di derivazione orientale, ermetica
e cristiana, con tracce palesi di gnosticismo.
SINGOLARE. Nella logica, si dice di un termine o di una proposizione denotante o
concernente una realtà individuale, come ad es.: Aristotele fu un filosofo.
SÌNOLO (gr. sýnolon, tutto insieme). Presso Aristotele, la sostanza, in quanto unità
composta di forma e materia.
SINTÀTTICA. Nella terminologia introdotta da C. Morris, la scienza della relazione
dei segni linguistici fra loro, indipendentemente dalle relazioni di questi con gli
oggetti designati e con gli interpreti. (V. SEMIOTICA.)
SÌNTESI. In Kant, ogni atto di conoscenza, in quanto unificazione di rappresentazioni
e, in genere, organizzazione e sistemazione del molteplice. (È questo anche oggi il