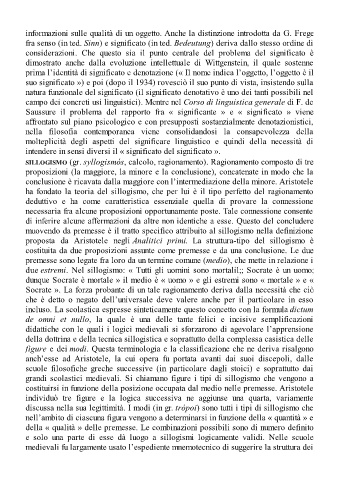Page 771 - Dizionario di Filosofia
P. 771
informazioni sulle qualità di un oggetto. Anche la distinzione introdotta da G. Frege
fra senso (in ted. Sinn) e significato (in ted. Bedeutung) deriva dallo stesso ordine di
considerazioni. Che questo sia il punto centrale del problema del significato è
dimostrato anche dalla evoluzione intellettuale di Wittgenstein, il quale sostenne
prima l’identità di significato e denotazione (« Il nome indica l’oggetto, l’oggetto è il
suo significato ») e poi (dopo il 1934) rovesciò il suo punto di vista, insistendo sulla
natura funzionale del significato (il significato denotativo è uno dei tanti possibili nel
campo dei concreti usi linguistici). Mentre nel Corso di linguistica generale di F. de
Saussure il problema del rapporto fra « significante » e « significato » viene
affrontato sul piano psicologico e con presupposti sostanzialmente denotazionistici,
nella filosofia contemporanea viene consolidandosi la consapevolezza della
molteplicità degli aspetti del significare linguistico e quindi della necessità di
intendere in sensi diversi il « significato del significato ».
SILLOGISMO (gr. syllogismós, calcolo, ragionamento). Ragionamento composto di tre
proposizioni (la maggiore, la minore e la conclusione), concatenate in modo che la
conclusione è ricavata dalla maggiore con l’intermediazione della minore. Aristotele
ha fondato la teoria del sillogismo, che per lui è il tipo perfetto del ragionamento
deduttivo e ha come caratteristica essenziale quella di provare la connessione
necessaria fra alcune proposizioni opportunamente poste. Tale connessione consente
di inferire alcune affermazioni da altre non identiche a esse. Questo del concludere
muovendo da premesse è il tratto specifico attribuito al sillogismo nella definizione
proposta da Aristotele negli Analitici primi. La struttura-tipo del sillogismo è
costituita da due proposizioni assunte come premesse e da una conclusione. Le due
premesse sono legate fra loro da un termine comune (medio), che mette in relazione i
due estremi. Nel sillogismo: « Tutti gli uomini sono mortalil;; Socrate è un uomo;
dunque Socrate è mortale » il medio è « uomo » e gli estremi sono « mortale » e «
Socrate ». La forza probante di un tale ragionamento deriva dalla necessità che ciò
che è detto o negato dell’universale deve valere anche per il particolare in esso
incluso. La scolastica espresse sinteticamente questo concetto con la formula dictum
de omni et nullo, la quale è una delle tante felici e incisive semplificazioni
didattiche con le quali i logici medievali si sforzarono di agevolare l’apprensione
della dottrina e della tecnica sillogistica e soprattutto della complessa casistica delle
figure e dei modi. Questa terminologia e la classificazione che ne deriva risalgono
anch’esse ad Aristotele, la cui opera fu portata avanti dai suoi discepoli, dalle
scuole filosofiche greche successive (in particolare dagli stoici) e soprattutto dai
grandi scolastici medievali. Si chiamano figure i tipi di sillogismo che vengono a
costituirsi in funzione della posizione occupata dal medio nelle premesse. Aristotele
individuò tre figure e la logica successiva ne aggiunse una quarta, variamente
discussa nella sua legittimità. I modi (in gr. trópoi) sono tutti i tipi di sillogismo che
nell’ambito di ciascuna figura vengono a determinarsi in funzione della « quantità » e
della « qualità » delle premesse. Le combinazioni possibili sono di numero definito
e solo una parte di esse dà luogo a sillogismi logicamente validi. Nelle scuole
medievali fu largamente usato l’espediente mnemotecnico di suggerire la struttura dei