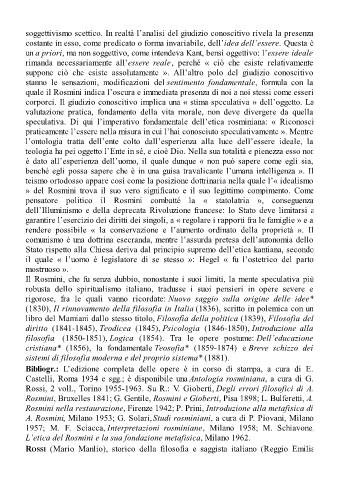Page 727 - Dizionario di Filosofia
P. 727
soggettivismo scettico. In realtà l’analisi del giudizio conoscitivo rivela la presenza
costante in esso, come predicato o forma invariabile, dell’idea dell’essere. Questa è
un a priori, ma non soggettivo, come intendeva Kant, bensì oggettivo: l’essere ideale
rimanda necessariamente all’essere reale, perché « ciò che esiste relativamente
suppone ciò che esiste assolutamente ». All’altro polo del giudizio conoscitivo
stanno le sensazioni, modificazioni del sentimento fondamentale, formula con la
quale il Rosmini indica l’oscura e immediata presenza di noi a noi stessi come esseri
corporei. Il giudizio conoscitivo implica una « stima speculativa » dell’oggetto. La
valutazione pratica, fondamento della vita morale, non deve divergere da quella
speculativa. Di qui l’imperativo fondamentale dell’etica rosminiana: « Riconosci
praticamente l’essere nella misura in cui l’hai conosciuto speculativamente ». Mentre
l’ontologia tratta dell’ente colto dall’esperienza alla luce dell’essere ideale, la
teologia ha pei oggetto l’Ente in sé, e cioè Dio. Nella sua totalità e pienezza esso non
è dato all’esperienza dell’uomo, il quale dunque « non può sapere come egli sia,
benché egli possa sapere che è in una guisa travalicante l’umana intelligenza ». Il
teismo ortodosso appare così come la posizione dottrinaria nella quale l’« idealismo
» del Rosmini trova il suo vero significato e il suo legittimo compimento. Come
pensatore politico il Rosmini combatté la « statolatria », conseguenza
dell’Illuminismo e della deprecata Rivoluzione francese: lo Stato deve limitarsi a
garantire l’esercizio dei diritti dei singoli, a « regolare i rapporti fra le famiglie » e a
rendere possibile « la conservazione e l’aumento ordinato della proprietà ». Il
comunismo è una dottrina esecranda, mentre l’assurda pretesa dell’autonomia dello
Stato rispetto alla Chiesa deriva dal principio supremo dell’etica kantiana, secondo
il quale « l’uomo è legislatore di se stesso »: Hegel « fu l’ostetrico del parto
mostruoso ».
Il Rosmini, che fu senza dubbio, nonostante i suoi limiti, la mente speculativa più
robusta dello spiritualismo italiano, tradusse i suoi pensieri in opere severe e
rigorose, fra le quali vanno ricordate: Nuovo saggio sulla origine delle idee*
(1830), Il rinnovamento della filosofia in Italia (1836), scritto in polemica con un
libro del Mamiani dallo stesso titolo, Filosofìa della politica (1839), Filosofia del
diritto (1841-1845), Teodicea (1845), Psicologia (1846-1850), Introduzione alla
filosofia (1850-1851), Logica (1854). Tra le opere postume: Dell’educazione
cristiana* (1856), la fondamentale Teosofia* (1859-1874) e Breve schizzo dei
sistemi di filosofia moderna e del proprio sistema* (1881).
Bibliogr.: L’edizione completa delle opere è in corso di stampa, a cura di E.
Castelli, Roma 1934 e sgg.; è disponibile una Antologia rosminiana, a cura di G.
Rossi, 2 voll., Torino 1955-1963. Su R.: V. Gioberti, Degli errori filosofici di A.
Rosmini, Bruxelles 1841; G. Gentile, Rosmini e Gioberti, Pisa 1898; L. Bulferetti, A.
Rosmini nella restaurazione, Firenze 1942; P. Prini, Introduzione alla metafisica di
A. Rosmini, Milano 1953; G. Solari, Studi rosminiani, a cura di P. Piovani, Milano
1957; M. F. Sciacca, Interpretazioni rosminiane, Milano 1958; M. Schiavone,
L’etica del Rosmini e la sua fondazione metafisica, Milano 1962.
ROSSI (Mario Manlio), storico della filosofia e saggista italiano (Reggio Emilia