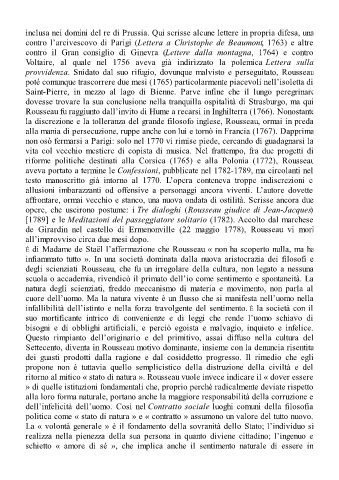Page 730 - Dizionario di Filosofia
P. 730
inclusa nei domini del re di Prussia. Qui scrisse alcune lettere in propria difesa, una
contro l’arcivescovo di Parigi (Lettera a Christophe de Beaumont, 1763) e altre
contro il Gran consiglio di Ginevra (Lettere dalla montagna, 1764) e contro
Voltaire, al quale nel 1756 aveva già indirizzato la polemica Lettera sulla
provvidenza. Snidato dal suo rifugio, dovunque malvisto e perseguitato, Rousseau
poté comunque trascorrere due mesi (1765) particolarmente piacevoli nell’isoletta di
Saint-Pierre, in mezzo al lago di Bienne. Parve infine che il lungo peregrinare
dovesse trovare la sua conclusione nella tranquilla ospitalità di Strasburgo, ma qui
Rousseau fu raggiunto dall’invito di Hume a recarsi in Inghilterra (1766). Nonostante
la discrezione e la tolleranza del grande filosofo inglese, Rousseau, ormai in preda
alla mania di persecuzione, ruppe anche con lui e tornò in Francia (1767). Dapprima
non osò fermarsi a Parigi: solo nel 1770 vi rimise piede, cercando di guadagnarsi la
vita col vecchio mestiere di copista di musica. Nel frattempo, fra due progetti di
riforme politiche destinati alla Corsica (1765) e alla Polonia (1772), Rousseau
aveva portato a termine le Confessioni, pubblicate nel 1782-1789, ma circolanti nel
testo manoscritto già intorno al 1770. L’opera conteneva troppe indiscrezioni e
allusioni imbarazzanti od offensive a personaggi ancora viventi. L’autore dovette
affrontare, ormai vecchio e stanco, una nuova ondata di ostilità. Scrisse ancora due
opere, che uscirono postume: i Tre dialoghi (Rousseau giudice di Jean-Jacques)
[1789] e le Meditazioni del passeggiatore solitario (1782). Accolto dal marchese
de Girardin nel castello di Ermenonville (22 maggio 1778), Rousseau vi morì
all’improvviso circa due mesi dopo.
È di Madame de Staël l’affermazione che Rousseau « non ha scoperto nulla, ma ha
infiammato tutto ». In una società dominata dalla nuova aristocrazia dei filosofi e
degli scienziati Rousseau, che fu un irregolare della cultura, non legato a nessuna
scuola o accademia, rivendicò il primato dell’io come sentimento e spontaneità. La
natura degli scienziati, freddo meccanismo di materia e movimento, non parla al
cuore dell’uomo. Ma la natura vivente è un flusso che si manifesta nell’uomo nella
infallibilità dell’istinto e nella forza travolgente del sentimento. È la società con il
suo mortificante intrico di convenienze e di leggi che rende l’uomo schiavo di
bisogni e di obblighi artificiali, e perciò egoista e malvagio, inquieto e infelice.
Questo rimpianto dell’originario e del primitivo, assai diffuso nella cultura del
Settecento, diventa in Rousseau motivo dominante, insieme con la denuncia risentita
dei guasti prodotti dalla ragione e dal cosiddetto progresso. Il rimedio che egli
propone non è tuttavia quello semplicistico della distruzione della civiltà e del
ritorno al mitico « stato di natura ». Rousseau vuole invece indicare il « dover essere
» di quelle istituzioni fondamentali che, proprio perché radicalmente deviate rispetto
alla loro forma naturale, portano anche la maggiore responsabilità della corruzione e
dell’infelicità dell’uomo. Così nel Contratto sociale luoghi comuni della filosofia
politica come « stato di natura » e « contratto » assumono un valore del tutto nuovo.
La « volontà generale » è il fondamento della sovranità dello Stato; l’individuo si
realizza nella pienezza della sua persona in quanto diviene cittadino; l’ingenuo e
schietto « amore di sé », che implica anche il sentimento naturale di essere in