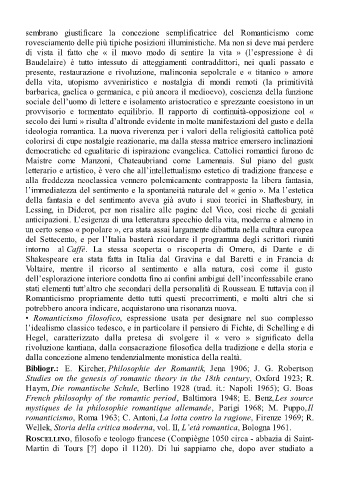Page 725 - Dizionario di Filosofia
P. 725
sembrano giustificare la concezione semplificatrice del Romanticismo come
rovesciamento delle più tipiche posizioni illuministiche. Ma non si deve mai perdere
di vista il fatto che « il nuovo modo di sentire la vita » (l’espressione è di
Baudelaire) è tutto intessuto di atteggiamenti contraddittori, nei quali passato e
presente, restaurazione e rivoluzione, malinconia sepolcrale e « titanico » amore
della vita, utopismo avveniristico e nostalgia di mondi remoti (la primitività
barbarica, gaelica o germanica, e più ancora il medioevo), coscienza della funzione
sociale dell’uomo di lettere e isolamento aristocratico e sprezzante coesistono in un
provvisorio e tormentato equilibrio. Il rapporto di continuità-opposizione col «
secolo dei lumi » risulta d’altronde evidente in molte manifestazioni del gusto e della
ideologia romantica. La nuova riverenza per i valori della religiosità cattolica poté
colorirsi di cupe nostalgie reazionarie, ma dalla stessa matrice emersero inclinazioni
democratiche ed egualitarie di ispirazione evangelica. Cattolici romantici furono de
Maistre come Manzoni, Chateaubriand come Lamennais. Sul piano del gusto
letterario e artistico, è vero che all’intellettualismo estetico di tradizione francese e
alla freddezza neoclassica vennero polemicamente contrapposte la libera fantasia,
l’immediatezza del sentimento e la spontaneità naturale del « genio ». Ma l’estetica
della fantasia e del sentimento aveva già avuto i suoi teorici in Shaftesbury, in
Lessing, in Diderot, per non risalire alle pagine del Vico, così ricche di geniali
anticipazioni. L’esigenza di una letteratura specchio della vita, moderna e almeno in
un certo senso « popolare », era stata assai largamente dibattuta nella cultura europea
del Settecento, e per l’Italia basterà ricordare il programma degli scrittori riuniti
intorno al Caffè. La stessa scoperta o riscoperta di Omero, di Dante e di
Shakespeare era stata fatta in Italia dal Gravina e dal Baretti e in Francia da
Voltaire, mentre il ricorso al sentimento e alla natura, così come il gusto
dell’esplorazione interiore condotta fino ai confini ambigui dell’inconfessabile erano
stati elementi tutt’altro che secondari della personalità di Rousseau. E tuttavia con il
Romanticismo propriamente detto tutti questi precorrimenti, e molti altri che si
potrebbero ancora indicare, acquistarono una risonanza nuova.
• Romanticismo filosofico, espressione usata per designare nel suo complesso
l’idealismo classico tedesco, e in particolare il pensiero di Fichte, di Schelling e di
Hegel, caratterizzato dalla pretesa di svolgere il « vero » significato della
rivoluzione kantiana, dalla consacrazione filosofica della tradizione e della storia e
dalla concezione almeno tendenzialmente monistica della realtà.
Bibliogr.: E. Kircher, Philosophie der Romantik, Jena 1906; J. G. Robertson,
Studies on the genesis of romantic theory in the 18th century, Oxford 1923; R.
Haym, Die romantische Schule, Berlino 1928 (trad. it.: Napoli 1965); G. Boas,
French philosophy of the romantic period, Baltimora 1948; E. Benz, Les source
mystiques de la philosophie romantique allemande, Parigi 1968; M. Puppo, Il
romanticismo, Roma 1963; C. Antoni, La lotta contro la ragione, Firenze 1969; R.
Wellek, Storia della critica moderna, vol. II, L’età romantica, Bologna 1961.
ROSCELLINO, filosofo e teologo francese (Compiègne 1050 circa - abbazia di Saint-
Martin di Tours [?] dopo il 1120). Di lui sappiamo che, dopo aver studiato a