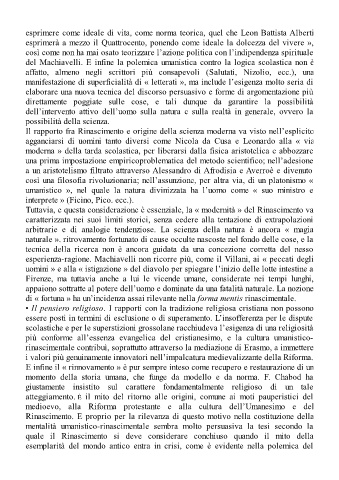Page 721 - Dizionario di Filosofia
P. 721
esprimere come ideale di vita, come norma teorica, quel che Leon Battista Alberti
esprimerà a mezzo il Quattrocento, ponendo come ideale la dolcezza del vivere »,
così come non ha mai osato teorizzare l’azione politica con l’indipendenza spirituale
del Machiavelli. E infine la polemica umanistica contro la logica scolastica non è
affatto, almeno negli scrittori più consapevoli (Salutati, Nizolio, ecc.), una
manifestazione di superficialità di « letterati », ma include l’esigenza molto seria di
elaborare una nuova tecnica del discorso persuasivo e forme di argomentazione più
direttamente poggiate sulle cose, e tali dunque da garantire la possibilità
dell’intervento attivo dell’uomo sulla natura c sulla realtà in generale, ovvero la
possibilità della scienza.
Il rapporto fra Rinascimento e origine della scienza moderna va visto nell’esplicito
agganciarsi di uomini tanto diversi come Nicola da Cusa e Leonardo alla « via
moderna » della tarda scolastica, per liberarsi dalla fisica aristotelica e abbozzare
una prima impostazione empiricoproblematica del metodo scientifico; nell’adesione
a un aristotelismo filtrato attraverso Alessandro di Afrodisia e Averroè e divenuto
così una filosofia rivoluzionaria; nell’assunzione, per altra via, di un platonismo «
umanistico », nel quale la natura divinizzata ha l’uomo come « suo ministro e
interprete » (Ficino, Pico. ecc.).
Tuttavia, e questa considerazione è essenziale, la « modernità » del Rinascimento va
caratterizzata nei suoi limiti storici, senza cedere alla tentazione di extrapolazioni
arbitrarie e di analogie tendenziose. La scienza della natura è ancora « magia
naturale ». ritrovamento fortunato di cause occulte nascoste nel fondo delle cose, e la
tecnica della ricerca non è ancora guidata da una concezione corretta del nesso
esperienza-ragione. Machiavelli non ricorre più, come il Villani, ai « peccati degli
uomini » e alla « istigazione » del diavolo per spiegare l’inizio delle lotte intestine a
Firenze, ma tuttavia anche a lui le vicende umane, considerate nei tempi lunghi,
appaiono sottratte al potere dell’uomo e dominate da una fatalità naturale. La nozione
di « fortuna » ha un’incidenza assai rilevante nella forma mentis rinascimentale.
• Il pensiero religioso. I rapporti con la tradizione religiosa cristiana non possono
essere posti in termini di esclusione o di superamento. L’insofferenza per le dispute
scolastiche e per le superstizioni grossolane racchiudeva l’esigenza di una religiosità
più conforme all’essenza evangelica del cristianesimo, e la cultura umanistico-
rinascimentale contribuì, soprattutto attraverso la mediazione di Erasmo, a immettere
i valori più genuinamente innovatori nell’impalcatura medievalizzante della Riforma.
E infine il « rinnovamento » è pur sempre inteso come recupero e restaurazione di un
momento della storia umana, che funge da modello e da norma. F. Chabod ha
giustamente insistito sul carattere fondamentalmente religioso di un tale
atteggiamento. È il mito del ritorno alle origini, comune ai moti pauperistici del
medioevo, alla Riforma protestante e alla cultura dell’Umanesimo e del
Rinascimento. E proprio per la rilevanza di questo motivo nella costituzione della
mentalità umanistico-rinascimentale sembra molto persuasiva la tesi secondo la
quale il Rinascimento si deve considerare conchiuso quando il mito della
esemplarità del mondo antico entra in crisi, come è evidente nella polemica del