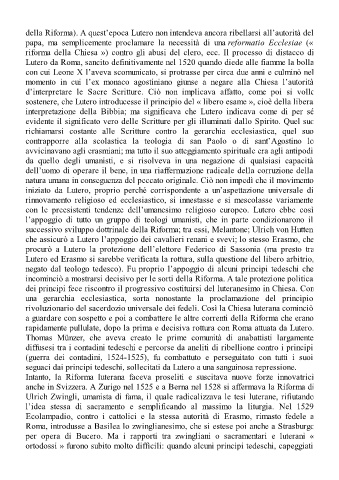Page 716 - Dizionario di Filosofia
P. 716
della Riforma). A quest’epoca Lutero non intendeva ancora ribellarsi all’autorità del
papa, ma semplicemente proclamare la necessità di una reformatio Ecclesiae («
riforma della Chiesa ») contro gli abusi del clero, ecc. Il processo di distacco di
Lutero da Roma, sancito definitivamente nel 1520 quando diede alle fiamme la bolla
con cui Leone X l’aveva scomunicato, si protrasse per circa due anni e culminò nel
momento in cui l’ex monaco agostiniano giunse a negare alla Chiesa l’autorità
d’interpretare le Sacre Scritture. Ciò non implicava affatto, come poi si volle
sostenere, che Lutero introducesse il principio del « libero esame », cioè della libera
interpretazione della Bibbia; ma significava che Lutero indicava come di per sé
evidente il significato vero delle Scritture per gli illuminati dallo Spirito. Quel suo
richiamarsi costante alle Scritture contro la gerarchia ecclesiastica, quel suo
contrapporre alla scolastica la teologia di san Paolo o di sant’Agostino lo
avvicinavano agli erasmiani; ma tutto il suo atteggiamento spirituale era agli antipodi
da quello degli umanisti, e si risolveva in una negazione di qualsiasi capacità
dell’uomo di operare il bene, in una riaffermazione radicale della corruzione della
natura umana in conseguenza del peccato originale. Ciò non impedì che il movimento
iniziato da Lutero, proprio perché corrispondente a un’aspettazione universale di
rinnovamento religioso ed ecclesiastico, si innestasse e si mescolasse variamente
con le preesistenti tendenze dell’umanesimo religioso europeo. Lutero ebbe così
l’appoggio di tutto un gruppo di teologi umanisti, che in parte condizionarono il
successivo sviluppo dottrinale della Riforma; tra essi, Melantone; Ulrich von Hutten,
che assicurò a Lutero l’appoggio dei cavalieri renani e svevi; lo stesso Erasmo, che
procurò a Lutero la protezione dell’elettore Federico di Sassonia (ma presto tra
Lutero ed Erasmo si sarebbe verificata la rottura, sulla questione del libero arbitrio,
negato dal teologo tedesco). Fu proprio l’appoggio di alcuni principi tedeschi che
incominciò a mostrarsi decisivo per le sorti della Riforma. A tale protezione politica
dei principi fece riscontro il progressivo costituirsi del luteranesimo in Chiesa. Con
una gerarchia ecclesiastica, sorta nonostante la proclamazione del principio
rivoluzionario del sacerdozio universale dei fedeli. Così la Chiesa luterana cominciò
a guardare con sospetto e poi a combattere le altre correnti della Riforma che erano
rapidamente pullulate, dopo la prima e decisiva rottura con Roma attuata da Lutero.
Thomas Münzer, che aveva creato le prime comunità di anabattisti largamente
diffusesi tra i contadini tedeschi e percorse da aneliti di ribellione contro i principi
(guerra dei contadini, 1524-1525), fu combattuto e perseguitato con tutti i suoi
seguaci dai principi tedeschi, sollecitati da Lutero a una sanguinosa repressione.
Intanto, la Riforma luterana faceva proseliti e suscitava nuove forze innovatrici
anche in Svizzera. A Zurigo nel 1525 e a Berna nel 1528 si affermava la Riforma di
Ulrich Zwingli, umanista di fama, il quale radicalizzava le tesi luterane, rifiutando
l’idea stessa di sacramento e semplificando al massimo la liturgia. Nel 1529
Ecolampadio, contro i cattolici e la stessa autorità di Erasmo, rimasto fedele a
Roma, introdusse a Basilea lo zwinglianesimo, che si estese poi anche a Strasburgo
per opera di Bucero. Ma i rapporti tra zwingliani o sacramentari e luterani «
ortodossi » furono subito molto diffìcili: quando alcuni principi tedeschi, capeggiati