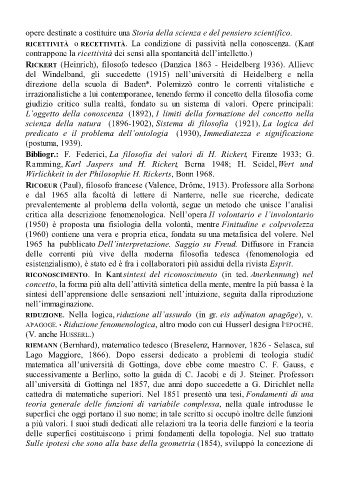Page 714 - Dizionario di Filosofia
P. 714
opere destinate a costituire una Storia della scienza e del pensiero scientifico.
RICETTIVITÀ o RECETTIVITÀ. La condizione di passività nella conoscenza. (Kant
contrappone la ricettività dei sensi alla spontaneità dell’intelletto.)
RICKERT (Heinrich), filosofo tedesco (Danzica 1863 - Heidelberg 1936). Allievo
del Windelband, gli succedette (1915) nell’università di Heidelberg e nella
direzione della scuola di Baden*. Polemizzò contro le correnti vitalistiche e
irrazionalistiche a lui contemporanee, tenendo fermo il concetto della filosofia come
giudizio critico sulla realtà, fondato su un sistema di valori. Opere principali:
L’oggetto della conoscenza (1892), I limiti della formazione del concetto nella
scienza della natura (1896-1902), Sistema di filosofia (1921), La logica del
predicato e il problema dell’ontologia (1930), Immediatezza e significazione
(postuma, 1939).
Bibliogr.: F. Federici, La filosofia dei valori di H. Rickert, Firenze 1933; G.
Ramming, Karl Jaspers und H. Rickert, Berna 1948; H. Seidel, Wert und
Wirlichkeit in der Philosophie H. Rickerts, Bonn 1968.
RICOEUR (Paul), filosofo francese (Valence, Drôme, 1913). Professore alla Sorbona
e dal 1965 alla facoltà di lettere di Nanterre, nelle sue ricerche, dedicate
prevalentemente al problema della volontà, segue un metodo che unisce l’analisi
critica alla descrizione fenomenologica. Nell’opera Il volontario e l’involontario
(1950) è proposta una fisiologia della volontà, mentre Finitudine e colpevolezza
(1960) contiene una vera e propria etica, fondata su una metafisica del volere. Nel
1965 ha pubblicato Dell’interpretazione. Saggio su Freud. Diffusore in Francia
delle correnti più vive della moderna filosofia tedesca (fenomenologia ed
esistenzialismo), è stato ed è fra i collaboratori più assidui della rivista Esprit.
RICONOSCIMENTO. In Kant sintesi del riconoscimento (in ted. Anerkennung) nel
concetto, la forma più alta dell’attività sintetica della mente, mentre la più bassa è la
sintesi dell’apprensione delle sensazioni nell’intuizione, seguita dalla riproduzione
nell’immaginazione.
RIDUZIONE. Nella logica, riduzione all’assurdo (in gr. eis adýnaton apagōge), v.
APAGOGE. • Riduzione fenomenologica, altro modo con cui Husserl designa l’EPOCHÈ.
(V. anche HUSSERL.)
RIEMANN (Bernhard), matematico tedesco (Breselenz, Hannover, 1826 - Selasca, sul
Lago Maggiore, 1866). Dopo essersi dedicato a problemi di teologia studiò
matematica all’università di Gottinga, dove ebbe come maestro C. F. Gauss, e
successivamente a Berlino, sotto la guida di C. Jacobi e di J. Steiner. Professore
all’università di Gottinga nel 1857, due anni dopo succedette a G. Dirichlet nella
cattedra di matematiche superiori. Nel 1851 presentò una tesi, Fondamenti di una
teoria generale delle funzioni di variabile complessa, nella quale introdusse le
superfici che oggi portano il suo nome; in tale scritto si occupò inoltre delle funzioni
a più valori. I suoi studi dedicati alle relazioni tra la teoria delle funzioni e la teoria
delle superfici costituiscono i primi fondamenti della topologia. Nel suo trattato
Sulle ipotesi che sono alla base della geometria (1854), sviluppò la concezione di