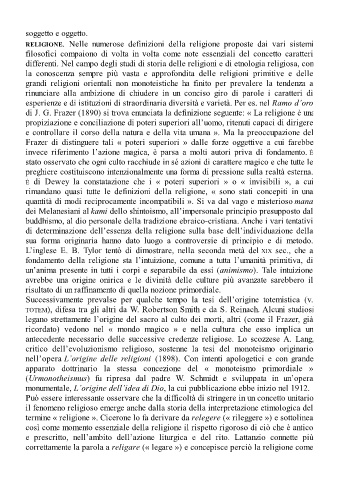Page 709 - Dizionario di Filosofia
P. 709
soggetto e oggetto.
RELIGIONE. Nelle numerose definizioni della religione proposte dai vari sistemi
filosofici compaiono di volta in volta come note essenziali del concetto caratteri
differenti. Nel campo degli studi di storia delle religioni e di etnologia religiosa, con
la conoscenza sempre più vasta e approfondita delle religioni primitive e delle
grandi religioni orientali non monoteistiche ha finito per prevalere la tendenza a
rinunciare alla ambizione di chiudere in un conciso giro di parole i caratteri di
esperienze e di istituzioni di straordinaria diversità e varietà. Per es. nel Ramo d’oro
di J. G. Frazer (1890) si trova enunciata la definizione seguente: « La religione è una
propiziazione e conciliazione di poteri superiori all’uomo, ritenuti capaci di dirigere
e controllare il corso della natura e della vita umana ». Ma la preoccupazione del
Frazer di distinguere tali « poteri superiori » dalle forze oggettive a cui farebbe
invece riferimento l’azione magica, è parsa a molti autori priva di fondamento. È
stato osservato che ogni culto racchiude in sé azioni di carattere magico e che tutte le
preghiere costituiscono intenzionalmente una forma di pressione sulla realtà esterna.
È di Dewey la constatazione che i « poteri superiori » o « invisibili », a cui
rimandano quasi tutte le definizioni della religione, « sono stati concepiti in una
quantità di modi reciprocamente incompatibili ». Si va dal vago e misterioso mana
dei Melanesiani al kami dello shintoismo, all’impersonale principio presupposto dal
buddhismo, al dio personale della tradizione ebraico-cristiana. Anche i vari tentativi
di determinazione dell’essenza della religione sulla base dell’individuazione della
sua forma originaria hanno dato luogo a controversie di principio e di metodo.
L’inglese E. B. Tylor tentò di dimostrare, nella seconda metà del XIX sec., che a
fondamento della religione sta l’intuizione, comune a tutta l’umanità primitiva, di
un’anima presente in tutti i corpi e separabile da essi (animismo). Tale intuizione
avrebbe una origine onirica e le divinità delle culture più avanzate sarebbero il
risultato di un raffinamento di quella nozione primordiale.
Successivamente prevalse per qualche tempo la tesi dell’origine totemistica (v.
TOTEM), difesa tra gli altri da W. Robertson Smith e da S. Reinach. Alcuni studiosi
legano strettamente l’origine del sacro al culto dei morti, altri (come il Frazer, già
ricordato) vedono nel « mondo magico » e nella cultura che esso implica un
antecedente necessario delle successive credenze religiose. Lo scozzese A. Lang,
critico dell’evoluzionismo religioso, sostenne la tesi del monoteismo originario
nell’opera L’origine delle religioni (1898). Con intenti apologetici e con grande
apparato dottrinario la stessa concezione del « monoteismo primordiale »
(Urmonotheismus) fu ripresa dal padre W. Schmidt e sviluppata in un’opera
monumentale, L’origine dell’idea di Dio, la cui pubblicazione ebbe inizio nel 1912.
Può essere interessante osservare che la difficoltà di stringere in un concetto unitario
il fenomeno religioso emerge anche dalla storia della interpretazione etimologica del
termine « religione ». Cicerone lo fa derivare da relegere (« rileggere ») e sottolinea
così come momento essenziale della religione il rispetto rigoroso di ciò che è antico
e prescritto, nell’ambito dell’azione liturgica e del rito. Lattanzio connette più
correttamente la parola a religare (« legare ») e concepisce perciò la religione come