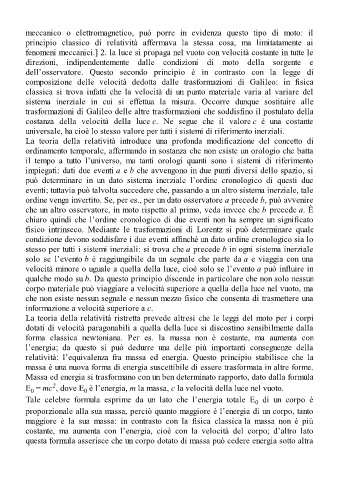Page 706 - Dizionario di Filosofia
P. 706
meccanico o elettromagnetico, può porre in evidenza questo tipo di moto: il
principio classico di relatività affermava la stessa cosa, ma limitatamente ai
fenomeni meccanici.] 2. la luce si propaga nel vuoto con velocità costante in tutte le
direzioni, indipendentemente dalle condizioni di moto della sorgente e
dell’osservatore. Questo secondo principio è in contrasto con la legge di
composizione delle velocità dedotta dalle trasformazioni di Galileo: in fisica
classica si trova infatti che la velocità di un punto materiale varia al variare del
sistema inerziale in cui si effettua la misura. Occorre dunque sostituire alle
trasformazioni di Galileo delle altre trasformazioni che soddisfino il postulato della
costanza della velocità della luce c. Ne segue che il valore c è una costante
universale, ha cioè lo stesso valore per tutti i sistemi di riferimento inerziali.
La teoria della relatività introduce una profonda modificazione del concetto di
ordinamento temporale, affermando in sostanza che non esiste un orologio che batta
il tempo a tutto l’universo, ma tanti orologi quanti sono i sistemi di riferimento
impiegati: dati due eventi a e b che avvengono in due punti diversi dello spazio, si
può determinare in un dato sistema inerziale l’ordine cronologico di questi due
eventi; tuttavia può talvolta succedere che, passando a un altro sistema inerziale, tale
ordine venga invertito. Se, per es., per un dato osservatore a precede b, può avvenire
che un altro osservatore, in moto rispetto al primo, veda invece che b precede a. È
chiaro quindi che l’ordine cronologico di due eventi non ha sempre un significato
fisico intrinseco. Mediante le trasformazioni di Lorentz si può determinare quale
condizione devono soddisfare i due eventi affinché un dato ordine cronologico sia lo
stesso per tutti i sistemi inerziali: si trova che a precede b in ogni sistema inerziale
solo se l’evento b è raggiungibile da un segnale che parte da a e viaggia con una
velocità minore o uguale a quella della luce, cioè solo se l’evento a può influire in
qualche modo su b. Da questo principio discende in particolare che non solo nessun
corpo materiale può viaggiare a velocità superiore a quella della luce nel vuoto, ma
che non esiste nessun segnale e nessun mezzo fisico che consenta di trasmettere una
informazione a velocità superiore a c.
La teoria della relatività ristretta prevede altresì che le leggi del moto per i corpi
dotati di velocità paragonabili a quella della luce si discostino sensibilmente dalla
forma classica newtoniana. Per es. la massa non è costante, ma aumenta con
l’energia; da questo si può dedurre una delle più importanti conseguenze della
relatività: l’equivalenza fra massa ed energia. Questo principio stabilisce che la
massa è una nuova forma di energia suscettibile di essere trasformata in altre forme.
Massa ed energia si trasformano con un ben determinato rapporto, dato dalla formula
2
E = mc , dove E è l’energia, m la massa, c la velocità della luce nel vuoto.
0
0
Tale celebre formula esprime da un lato che l’energia totale E di un corpo è
0
proporzionale alla sua massa, perciò quanto maggiore è l’energia di un corpo, tanto
maggiore è la sua massa: in contrasto con la fìsica classica la massa non è più
costante, ma aumenta con l’energia, cioè con la velocità del corpo; d’altro lato
questa formula asserisce che un corpo dotato di massa può cedere energia sotto altra