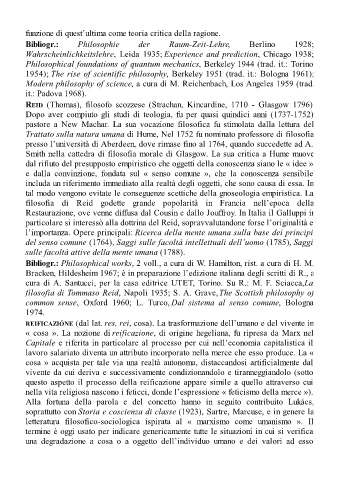Page 703 - Dizionario di Filosofia
P. 703
funzione di quest’ultima come teoria critica della ragione.
Bibliogr.: Philosophie der Raum-Zeit-Lehre, Berlino 1928;
Wahrscheinlichkeitslehre, Leida 1935; Experience and prediction, Chicago 1938;
Philosophical foundations of quantum mechanics, Berkeley 1944 (trad. it.: Torino
1954); The rise of scientific philosophy, Berkeley 1951 (trad. it.: Bologna 1961);
Modern philosophy of science, a cura di M. Reichenbach, Los Angeles 1959 (trad.
it.: Padova 1968).
REID (Thomas), filosofo scozzese (Strachan, Kincardine, 1710 - Glasgow 1796).
Dopo aver compiuto gli studi di teologia, fu per quasi quindici anni (1737-1752)
pastore a New Machar. La sua vocazione filosofica fu stimolata dalla lettura del
Trattato sulla natura umana di Hume, Nel 1752 fu nominato professore di filosofia
presso l’università di Aberdeen, dove rimase fino al 1764, quando succedette ad A.
Smith nella cattedra di filosofia morale di Glasgow. La sua critica a Hume muove
dal rifiuto del presupposto empiristico che oggetti della conoscenza siano le « idee »
e dalla convinzione, fondata sul « senso comune », che la conoscenza sensibile
includa un riferimento immediato alla realtà degli oggetti, che sono causa di essa. In
tal modo vengono evitate le conseguenze scettiche della gnoseologia empiristica. La
filosofia di Reid godette grande popolarità in Francia nell’epoca della
Restaurazione, ove venne diffusa dal Cousin e dallo Jouffroy. In Italia il Galluppi in
particolare si interessò alla dottrina del Reid, sopravvalutandone forse l’originalità e
l’importanza. Opere principali: Ricerca della mente umana sulla base dei principi
del senso comune (1764), Saggi sulle facoltà intellettuali dell’uomo (1785), Saggi
sulle facoltà attive della mente umana (1788).
Bibliogr.: Philosophical works, 2 voll., a cura di W. Hamilton, rist. a cura di H. M.
Bracken, Hildesheim 1967; è in preparazione l’edizione italiana degli scritti di R., a
cura di A. Santucci, per la casa editrice UTET, Torino. Su R.: M. F. Sciacca, La
filosofia di Tommaso Reid, Napoli 1935; S. A. Grave, The Scottish philosophy of
common sense, Oxford 1960; L. Turco, Dal sistema al senso comune, Bologna
1974.
REIFICAZIÓNE (dal lat. res, rei, cosa). La trasformazione dell’umano e del vivente in
« cosa ». La nozione di reificazione, di origine hegeliana, fu ripresa da Marx nel
Capitale e riferita in particolare al processo per cui nell’economia capitalistica il
lavoro salariato diventa un attributo incorporato nella merce che esso produce. La «
cosa » acquista per tale via una realtà autonoma, distaccandosi artificialmente dal
vivente da cui deriva e successivamente condizionandolo e tiranneggiandolo (sotto
questo aspetto il processo della reificazione appare simile a quello attraverso cui
nella vita religiosa nascono i feticci, donde l’espressione « feticismo della merce »).
Alla fortuna della parola e del concetto hanno in seguito contribuito Lukács,
soprattutto con Storia e coscienza di classe (1923), Sartre, Marcuse, e in genere la
letteratura filosofico-sociologica ispirata al « marxismo come umanismo ». Il
termine è oggi usato per indicare genericamente tutte le situazioni in cui si verifica
una degradazione a cosa o a oggetto dell’individuo umano e dei valori ad esso