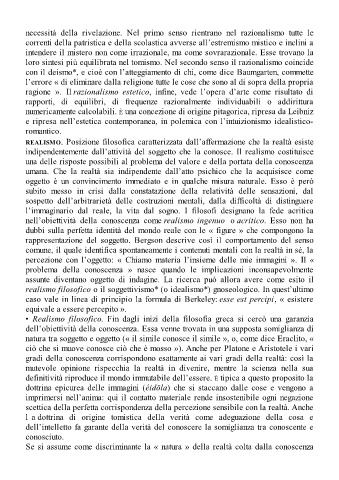Page 699 - Dizionario di Filosofia
P. 699
necessità della rivelazione. Nel primo senso rientrano nel razionalismo tutte le
correnti della patristica e della scolastica avverse all’estremismo mistico e inclini a
intendere il mistero non come irrazionale, ma come sovrarazionale. Esse trovano la
loro sintesi più equilibrata nel tomismo. Nel secondo senso il razionalismo coincide
con il deismo*, e cioè con l’atteggiamento di chi, come dice Baumgarten, commette
l’errore « di eliminare dalla religione tutte le cose che sono al di sopra della propria
ragione ». Il razionalismo estetico, infine, vede l’opera d’arte come risultato di
rapporti, di equilibri, di frequenze razionalmente individuabili o addirittura
numericamente calcolabili. È una concezione di origine pitagorica, ripresa da Leibniz
e ripresa nell’estetica contemporanea, in polemica con l’intuizionismo idealistico-
romantico.
REALISMO. Posizione filosofica caratterizzata dall’affermazione che la realtà esiste
indipendentemente dall’attività del soggetto che la conosce. Il realismo costituisce
una delle risposte possibili al problema del valore e della portata della conoscenza
umana. Che la realtà sia indipendente dall’atto psichico che la acquisisce come
oggetto è un convincimento immediato e in qualche misura naturale. Esso è però
subito messo in crisi dalla constatazione della relatività delle sensazioni, dal
sospetto dell’arbitrarietà delle costruzioni mentali, dalla difficoltà di distinguere
l’immaginario dal reale, la vita dal sogno. I filosofi designano la fede acritica
nell’obiettività della conoscenza come realismo ingenuo o acritico. Esso non ha
dubbi sulla perfetta identità del mondo reale con le « figure » che compongono la
rappresentazione del soggetto. Bergson descrive così il comportamento del senso
comune, il quale identifica spontaneamente i contenuti mentali con la realtà in sé, la
percezione con l’oggetto: « Chiamo materia l’insieme delle mie immagini ». Il «
problema della conoscenza » nasce quando le implicazioni inconsapevolmente
assunte diventano oggetto di indagine. La ricerca può allora avere come esito il
realismo filosofico o il soggettivismo* (o idealismo*) gnoseologico. In quest’ultimo
caso vale in linea di principio la formula di Berkeley: esse est percipi, « esistere
equivale a essere percepito ».
• Realismo filosofico. Fin dagli inizi della filosofia greca si cercò una garanzia
dell’obiettività della conoscenza. Essa venne trovata in una supposta somiglianza di
natura tra soggetto e oggetto (« il simile conosce il simile », o, come dice Eraclito, «
ciò che si muove conosce ciò che è mosso »). Anche per Platone e Aristotele i vari
gradi della conoscenza corrispondono esattamente ai vari gradi della realtà: così la
mutevole opinione rispecchia la realtà in divenire, mentre la scienza nella sua
definitività riproduce il mondo immutabile dell’essere. È tipica a questo proposito la
dottrina epicurea delle immagini (éidōla) che si staccano dalle cose e vengono a
imprimersi nell’anima: qui il contatto materiale rende insostenibile ogni negazione
scettica della perfetta corrispondenza della percezione sensibile con la realtà. Anche
l a dottrina di origine tomistica della verità come adeguazione della cosa e
dell’intelletto fa garante della verità del conoscere la somiglianza tra conoscente e
conosciuto.
Se si assume come discriminante la « natura » della realtà colta dalla conoscenza