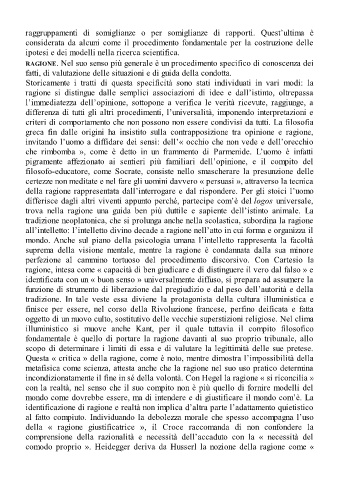Page 694 - Dizionario di Filosofia
P. 694
raggruppamenti di somiglianze o per somiglianze di rapporti. Quest’ultima è
considerata da alcuni come il procedimento fondamentale per la costruzione delle
ipotesi e dei modelli nella ricerca scientifica.
RAGIONE. Nel suo senso più generale è un procedimento specifico di conoscenza dei
fatti, di valutazione delle situazioni e di guida della condotta.
Storicamente i tratti di questa specificità sono stati individuati in vari modi: la
ragione si distingue dalle semplici associazioni di idee e dall’istinto, oltrepassa
l’immediatezza dell’opinione, sottopone a verifica le verità ricevute, raggiunge, a
differenza di tutti gli altri procedimenti, l’universalità, imponendo interpretazioni e
criteri di comportamento che non possono non essere condivisi da tutti. La filosofia
greca fin dalle origini ha insistito sulla contrapposizione tra opinione e ragione,
invitando l’uomo a diffidare dei sensi: dell’« occhio che non vede e dell’orecchio
che rimbomba », come è detto in un frammento di Parmenide. L’uomo è infatti
pigramente affezionato ai sentieri più familiari dell’opinione, e il compito del
filosofo-educatore, come Socrate, consiste nello smascherare la presunzione delle
certezze non meditate e nel fare gli uomini davvero « persuasi », attraverso la tecnica
della ragione rappresentata dall’interrogare e dal rispondere. Per gli stoici l’uomo
differisce dagli altri viventi appunto perché, partecipe com’è del logos universale,
trova nella ragione una guida ben più duttile e sapiente dell’istinto animale. La
tradizione neoplatonica, che si prolunga anche nella scolastica, subordina la ragione
all’intelletto: l’intelletto divino decade a ragione nell’atto in cui forma e organizza il
mondo. Anche sul piano della psicologia umana l’intelletto rappresenta la facoltà
suprema della visione mentale, mentre la ragione è condannata dalla sua minore
perfezione al cammino tortuoso del procedimento discorsivo. Con Cartesio la
ragione, intesa come « capacità di ben giudicare e di distinguere il vero dal falso » e
identificata con un « buon senso » universalmente diffuso, si prepara ad assumere la
funzione di strumento di liberazione dal pregiudizio e dal peso dell’autorità e della
tradizione. In tale veste essa diviene la protagonista della cultura illuministica e
finisce per essere, nel corso della Rivoluzione francese, perfino deificata e fatta
oggetto di un nuovo culto, sostitutivo delle vecchie superstizioni religiose. Nel clima
illuministico si muove anche Kant, per il quale tuttavia il compito filosofico
fondamentale è quello di portare la ragione davanti al suo proprio tribunale, allo
scopo di determinare i limiti di essa e di valutare la legittimità delle sue pretese.
Questa « critica » della ragione, come è noto, mentre dimostra l’impossibilità della
metafisica come scienza, attesta anche che la ragione nel suo uso pratico determina
incondizionatamente il fine in sé della volontà. Con Hegel la ragione « si riconcilia »
con la realtà, nel senso che il suo compito non è più quello di fornire modelli del
mondo come dovrebbe essere, ma di intendere e di giustificare il mondo com’è. La
identificazione di ragione e realtà non implica d’altra parte l’adattamento quietistico
al fatto compiuto. Individuando la debolezza morale che spesso accompagna l’uso
della « ragione giustificatrice », il Croce raccomanda di non confondere la
comprensione della razionalità e necessità dell’accaduto con la « necessità del
comodo proprio ». Heidegger deriva da Husserl la nozione della ragione come «