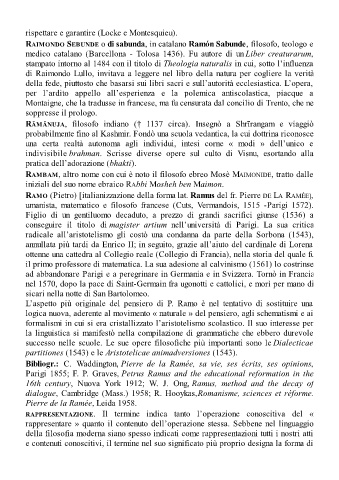Page 696 - Dizionario di Filosofia
P. 696
rispettare e garantire (Locke e Montesquieu).
RAIMONDO SEBUNDE o di sabunda, in catalano Ramón Sabunde, filosofo, teologo e
medico catalano (Barcellona - Tolosa 1436). Fu autore di un Liber creaturarum,
stampato intorno al 1484 con il titolo di Theologia naturalis in cui, sotto l’influenza
di Raimondo Lullo, invitava a leggere nel libro della natura per cogliere la verità
della fede, piuttosto che basarsi sui libri sacri e sull’autorità ecclesiastica. L’opera,
per l’ardito appello all’esperienza e la polemica antiscolastica, piacque a
Montaigne, che la tradusse in francese, ma fu censurata dal concilio di Trento, che ne
soppresse il prologo.
RĀMĀNUJA, filosofo indiano († 1137 circa). Insegnò a Shrīrangam e viaggiò
probabilmente fino al Kashmir. Fondò una scuola vedantica, la cui dottrina riconosce
una certa realtà autonoma agli individui, intesi corne « modi » dell’unico e
indivisibile brahman. Scrisse diverse opere sul culto di Visnu, esortando alla
pratica dell’adorazione (bhakti).
RAMBAM, altro nome con cui è noto il filosofo ebreo Mosè MAIMONIDE, tratto dalle
iniziali del suo nome ebraico RAbbi Mosheh ben Maimon.
RAMO (Pietro) [italianizzazione della forma lat. Ramus del fr. Pierre DE LA RAMÉE],
umanista, matematico e filosofo francese (Cuts, Vermandois, 1515 -Parigi 1572).
Figlio di un gentiluomo decaduto, a prezzo di grandi sacrifici giunse (1536) a
conseguire il titolo di magister artium nell’università di Parigi. La sua critica
radicale all’aristotelismo gli costò una condanna da parte della Sorbona (1543),
annullata più tardi da Enrico II; in seguito, grazie all’aiuto del cardinale di Lorena,
ottenne una cattedra al Collegio reale (Collegio di Francia), nella storia del quale fu
il primo professore di matematica. La sua adesione al calvinismo (1561) lo costrinse
ad abbandonare Parigi e a peregrinare in Germania e in Svizzera. Tornò in Francia
nel 1570, dopo la pace di Saint-Germain fra ugonotti e cattolici, e morì per mano di
sicari nella notte di San Bartolomeo.
L’aspetto più originale del pensiero di P. Ramo è nel tentativo di sostituire una
logica nuova, aderente al movimento « naturale » del pensiero, agli schematismi e ai
formalismi in cui si era cristallizzato l’aristotelismo scolastico. Il suo interesse per
la linguistica si manifestò nella compilazione di grammatiche che ebbero durevole
successo nelle scuole. Le sue opere filosofiche più importanti sono le Dialecticae
partitiones (1543) e le Aristotelicae animadversiones (1543).
Bibliogr.: C. Waddington, Pierre de la Ramée, sa vie, ses écrits, ses opinions,
Parigi 1855; F. P. Graves, Petrus Ramus and the educational reformation in the
16th century, Nuova York 1912; W. J. Ong, Ramus, method and the decay of
dialogue, Cambridge (Mass.) 1958; R. Hooykas, Romanisme, sciences et réforme.
Pierre de la Ramée, Leida 1958.
RAPPRESENTAZIONE. Il termine indica tanto l’operazione conoscitiva del «
rappresentare » quanto il contenuto dell’operazione stessa. Sebbene nel linguaggio
della filosofia moderna siano spesso indicati come rappresentazioni tutti i nostri atti
e contenuti conoscitivi, il termine nel suo significato più proprio designa la forma di