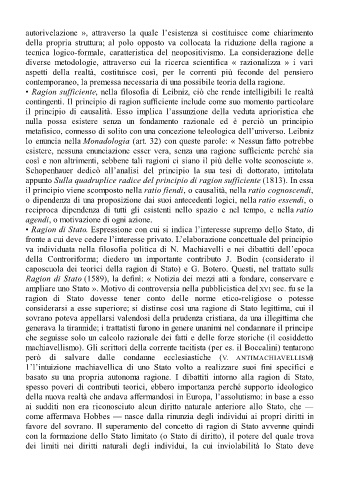Page 695 - Dizionario di Filosofia
P. 695
autorivelazione », attraverso la quale l’esistenza si costituisce come chiarimento
della propria struttura; al polo opposto va collocata la riduzione della ragione a
tecnica logico-formale, caratteristica del neopositivismo. La considerazione delle
diverse metodologie, attraverso cui la ricerca scientifica « razionalizza » i vari
aspetti della realtà, costituisce così, per le correnti più feconde del pensiero
contemporaneo, la premessa necessaria di una possibile teoria della ragione.
• Ragion sufficiente, nella filosofia di Leibniz, ciò che rende intelligibili le realtà
contingenti. Il principio di ragion sufficiente include come suo momento particolare
il principio di causalità. Esso implica l’assunzione della veduta aprioristica che
nulla possa esistere senza un fondamento razionale ed è perciò un principio
metafisico, connesso di solito con una concezione teleologica dell’universo. Leibniz
lo enuncia nella Monadologia (art. 32) con queste parole: « Nessun fatto potrebbe
esistere, nessuna enunciazione esser vera, senza una ragione sufficiente perché sia
così e non altrimenti, sebbene tali ragioni ci siano il più delle volte sconosciute ».
Schopenhauer dedicò all’analisi del principio la sua tesi di dottorato, intitolata
appunto Sulla quadruplice radice del principio di ragion sufficiente (1813). In essa
il principio viene scomposto nella ratio fiendi, o causalità, nella ratio cognoscendi,
o dipendenza di una proposizione dai suoi antecedenti logici, nella ratio essendi, o
reciproca dipendenza di tutti gli esistenti nello spazio e nel tempo, e nella ratio
agendi, o motivazione di ogni azione.
• Ragion di Stato. Espressione con cui si indica l’interesse supremo dello Stato, di
fronte a cui deve cedere l’interesse privato. L’elaborazione concettuale del principio
va individuata nella filosofia politica di N. Machiavelli e nei dibattiti dell’epoca
della Controriforma; diedero un importante contributo J. Bodin (considerato il
caposcuola dei teorici della ragion di Stato) e G. Botero. Questi, nel trattato sulla
Ragion di Stato (1589), la definì: « Notizia dei mezzi atti a fondare, conservare e
ampliare uno Stato ». Motivo di controversia nella pubblicistica del XVI sec. fu se la
ragion di Stato dovesse tener conto delle norme etico-religiose o potesse
considerarsi a esse superiore; si distinse così una ragione di Stato legittima, cui il
sovrano poteva appellarsi valendosi della prudenza cristiana, da una illegittima che
generava la tirannide; i trattatisti furono in genere unanimi nel condannare il principe
che seguisse solo un calcolo razionale dei fatti e delle forze storiche (il cosiddetto
machiavellismo). Gli scrittori della corrente tacitista (per es. il Boccalini) tentarono
però di salvare dalle condanne ecclesiastiche (V. ANTIMACHIAVELLISMO)
1’l’intuizione machiavellica di uno Stato volto a realizzare suoi fini specifici e
basato su una propria autonoma ragione. I dibattiti intorno alla ragion di Stato,
spesso poveri di contributi teorici, ebbero importanza perché supporto ideologico
della nuova realtà che andava affermandosi in Europa, l’assolutismo: in base a esso
ai sudditi non era riconosciuto alcun diritto naturale anteriore allo Stato, che —
come affermava Hobbes — nasce dalla rinunzia degli individui ai propri diritti in
favore del sovrano. Il superamento del concetto di ragion di Stato avvenne quindi
con la formazione dello Stato limitato (o Stato di diritto), il potere del quale trova
dei limiti nei diritti naturali degli individui, la cui inviolabilità lo Stato deve