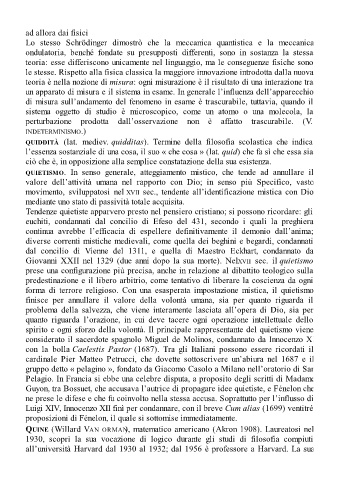Page 691 - Dizionario di Filosofia
P. 691
ad allora dai fisici
Lo stesso Schrödinger dimostrò che la meccanica quantistica e la meccanica
ondulatoria, benché fondate su presupposti differenti, sono in sostanza la stessa
teoria: esse differiscono unicamente nel linguaggio, ma le conseguenze fisiche sono
le stesse. Rispetto alla fisica classica la maggiore innovazione introdotta dalla nuova
teoria è nella nozione di misura: ogni misurazione è il risultato di una interazione tra
un apparato di misura e il sistema in esame. In generale l’influenza dell’apparecchio
di misura sull’andamento del fenomeno in esame è trascurabile, tuttavia, quando il
sistema oggetto di studio è microscopico, come un atomo o una molecola, la
perturbazione prodotta dall’osservazione non è affatto trascurabile. (V.
INDETERMINISMO.)
QUIDDITÀ (lat. mediev. quidditas). Termine della filosofia scolastica che indica
l’essenza sostanziale di una cosa, il suo « che cosa » (lat. quid) che fa sì che essa sia
ciò che è, in opposizione alla semplice constatazione della sua esistenza.
QUIETISMO. In senso generale, atteggiamento mistico, che tende ad annullare il
valore dell’attività umana nel rapporto con Dio; in senso più Specifico, vasto
movimento, sviluppatosi nel XVII sec., tendente all’identificazione mistica con Dio
mediante uno stato di passività totale acquisita.
Tendenze quietiste apparvero presto nel pensiero cristiano; si possono ricordare: gli
euchiti, condannati dal concilio di Efeso del 431, secondo i quali la preghiera
continua avrebbe l’efficacia di espellere definitivamente il demonio dall’anima;
diverse correnti mistiche medievali, come quella dei beghini e begardi, condannati
dal concilio di Vienne del 1311, e quella di Maestro Eckhart, condannato da
Giovanni XXII nel 1329 (due anni dopo la sua morte). Nel XVII sec. il quietismo
prese una configurazione più precisa, anche in relazione al dibattito teologico sulla
predestinazione e il libero arbitrio, come tentativo di liberare la coscienza da ogni
forma di terrore religioso. Con una esasperata impostazione mistica, il quietismo
finisce per annullare il valore della volontà umana, sia per quanto riguarda il
problema della salvezza, che viene interamente lasciata all’opera di Dio, sia per
quanto riguarda l’orazione, in cui deve tacere ogni operazione intellettuale dello
spirito e ogni sforzo della volontà. Il principale rappresentante del quietismo viene
considerato il sacerdote spagnolo Miguel de Molinos, condannato da Innocenzo XI
con la bolla Caelestis Pastor (1687). Tra gli Italiani possono essere ricordati il
cardinale Pier Matteo Petrucci, che dovette sottoscrivere un’abiura nel 1687 e il
gruppo detto « pelagino », fondato da Giacomo Casolo a Milano nell’oratorio di San
Pelagio. In Francia si ebbe una celebre disputa, a proposito degli scritti di Madame
Guyon, tra Bossuet, che accusava l’autrice di propagare idee quietiste, e Fénelon che
ne prese le difese e che fu coinvolto nella stessa accusa. Soprattutto per l’influsso di
Luigi XIV, Innocenzo XII finì per condannare, con il breve Cum alias (1699) ventitré
proposizioni di Fénelon, il quale si sottomise immediatamente.
QUINE (Willard VAN ORMAN), matematico americano (Akron 1908). Laureatosi nel
1930, scoprì la sua vocazione di logico durante gli studi di filosofia compiuti
all’università Harvard dal 1930 al 1932; dal 1956 è professore a Harvard. La sua