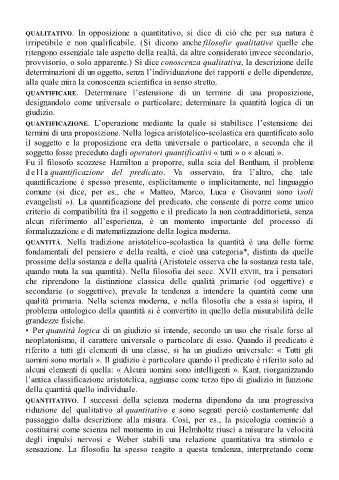Page 689 - Dizionario di Filosofia
P. 689
QUALITATIVO. In opposizione a quantitativo, si dice di ciò che per sua natura è
irripetibile e non qualificabile. (Si dicono anche filosofie qualitative quelle che
ritengono essenziale tale aspetto della realtà, da altre considerato invece secondario,
provvisorio, o solo apparente.) Si dice conoscenza qualitativa, la descrizione delle
determinazioni di un oggetto, senza l’individuazione dei rapporti e delle dipendenze,
alla quale mira la conoscenza scientifica in senso stretto.
QUANTIFICARE. Determinare l’estensione di un termine di una proposizione,
designandolo come universale o particolare; determinare la quantità logica di un
giudizio.
QUANTIFICAZIONE. L’operazione mediante la quale si stabilisce l’estensione dei
termini di una proposizione. Nella logica aristotelico-scolastica era quantificato solo
il soggetto e la proposizione era detta universale o particolare, a seconda che il
soggetto fosse preceduto dagli operatori quantificativi « tutti » o « alcuni ».
Fu il filosofo scozzese Hamilton a proporre, sulla scia del Bentham, il problema
d e l l a quantificazione del predicato. Va osservato, fra l’altro, che tale
quantificazione è spesso presente, esplicitamente o implicitamente, nel linguaggio
comune (si dice, per es., che « Matteo, Marco, Luca e Giovanni sono i soli
evangelisti »). La quantificazione del predicato, che consente di porre come unico
criterio di compatibilità fra il soggetto e il predicato la non contraddittorietà, senza
alcun riferimento all’esperienza, è un momento importante del processo di
formalizzazione e di matematizzazione della logica moderna.
QUANTITÀ. Nella tradizione aristotelico-scolastica la quantità è una delle forme
fondamentali del pensiero e della realtà, e cioè una categoria*, distinta da quelle
prossime della sostanza e della qualità (Aristotele osserva che la sostanza resta tale,
quando muta la sua quantità). Nella filosofia dei secc. XVII e XVIII, tra i pensatori
che riprendono la distinzione classica delle qualità primarie (od oggettive) e
secondarie (o soggettive), prevale la tendenza a intendere la quantità come una
qualità primaria. Nella scienza moderna, e nella filosofia che a essa si ispira, il
problema ontologico della quantità si è convertito in quello della misurabilità delle
grandezze fisiche.
• Per quantità logica di un giudizio si intende, secondo un uso che risale forse al
neoplatonismo, il carattere universale o particolare di esso. Quando il predicato è
riferito a tutti gli elementi di una classe, si ha un giudizio universale: « Tutti gli
uomini sono mortali ». Il giudizio è particolare quando il predicato è riferito solo ad
alcuni elementi di quella: « Alcuni uomini sono intelligenti ». Kant, riorganizzando
l’antica classificazione aristotelica, aggiunse come terzo tipo di giudizio in funzione
della quantità quello individuale.
QUANTITATIVO. I successi della scienza moderna dipendono da una progressiva
riduzione del qualitativo al quantitativo e sono segnati perciò costantemente dal
passaggio dalla descrizione alla misura. Così, per es., la psicologia cominciò a
costituirsi come scienza nel momento in cui Helmholtz riuscì a misurare la velocità
degli impulsi nervosi e Weber stabilì una relazione quantitativa tra stimolo e
sensazione. La filosofia ha spesso reagito a questa tendenza, interpretando come