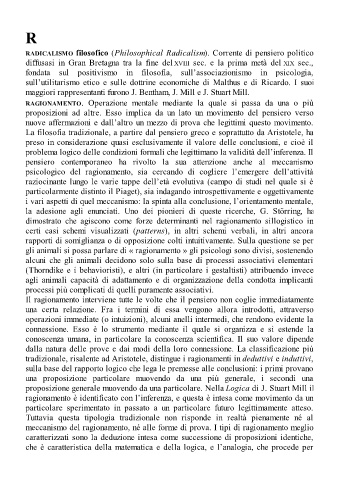Page 693 - Dizionario di Filosofia
P. 693
R
RADICALISMO filosofico (Philosophical Radicalism). Corrente di pensiero politico
diffusasi in Gran Bretagna tra la fine del XVIII sec. e la prima metà del XIX sec.,
fondata sul positivismo in filosofia, sull’associazionismo in psicologia,
sull’utilitarismo etico e sulle dottrine economiche di Malthus e di Ricardo. I suoi
maggiori rappresentanti furono J. Bentham, J. Mill e J. Stuart Mill.
RAGIONAMENTO. Operazione mentale mediante la quale si passa da una o più
proposizioni ad altre. Esso implica da un lato un movimento del pensiero verso
nuove affermazioni e dall’altro un mezzo di prova che legittimi questo movimento.
La filosofia tradizionale, a partire dal pensiero greco e soprattutto da Aristotele, ha
preso in considerazione quasi esclusivamente il valore delle conclusioni, e cioè il
problema logico delle condizioni formali che legittimano la validità dell’inferenza. Il
pensiero contemporaneo ha rivolto la sua attenzione anche al meccanismo
psicologico del ragionamento, sia cercando di cogliere l’emergere dell’attività
raziocinante lungo le varie tappe dell’età evolutiva (campo di studi nel quale si è
particolarmente distinto il Piaget), sia indagando introspettivamente e oggettivamente
i vari aspetti di quel meccanismo: la spinta alla conclusione, l’orientamento mentale,
la adesione agli enunciati. Uno dei pionieri di queste ricerche, G. Störring, ha
dimostrato che agiscono come forze determinanti nel ragionamento sillogistico in
certi casi schemi visualizzati (patterns), in altri schemi verbali, in altri ancora
rapporti di somiglianza o di opposizione colti intuitivamente. Sulla questione se per
gli animali si possa parlare di « ragionamento » gli psicologi sono divisi, sostenendo
alcuni che gli animali decidono solo sulla base di processi associativi elementari
(Thorndike e i behavioristi), e altri (in particolare i gestaltisti) attribuendo invece
agli animali capacità di adattamento e di organizzazione della condotta implicanti
processi più complicati di quelli puramente associativi.
Il ragionamento interviene tutte le volte che il pensiero non coglie immediatamente
una certa relazione. Fra i termini di essa vengono allora introdotti, attraverso
operazioni immediate (o intuizioni), alcuni anelli intermedi, che rendono evidente la
connessione. Esso è lo strumento mediante il quale si organizza e si estende la
conoscenza umana, in particolare la conoscenza scientifica. Il suo valore dipende
dalla natura delle prove e dai modi della loro connessione. La classificazione più
tradizionale, risalente ad Aristotele, distingue i ragionamenti in deduttivi e induttivi,
sulla base del rapporto logico che lega le premesse alle conclusioni: i primi provano
una proposizione particolare muovendo da una più generale, i secondi una
proposizione generale muovendo da una particolare. Nella Logica di J. Stuart Mill il
ragionamento è identificato con l’inferenza, e questa è intesa come movimento da un
particolare sperimentato in passato a un particolare futuro legittimamente atteso.
Tuttavia questa tipologia tradizionale non risponde in realtà pienamente né al
meccanismo del ragionamento, né alle forme di prova. I tipi di ragionamento meglio
caratterizzati sono la deduzione intesa come successione di proposizioni identiche,
che è caratteristica della matematica e della logica, e l’analogia, che procede per