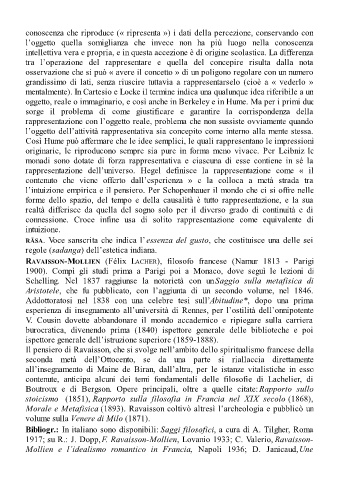Page 697 - Dizionario di Filosofia
P. 697
conoscenza che riproduce (« ripresenta ») i dati della percezione, conservando con
l’oggetto quella somiglianza che invece non ha più luogo nella conoscenza
intellettiva vera e propria, e in questa accezione è di origine scolastica. La differenza
tra l’operazione del rappresentare e quella del concepire risulta dalla nota
osservazione che si può « avere il concetto » di un poligono regolare con un numero
grandissimo di lati, senza riuscire tuttavia a rappresentarselo (cioè a « vederlo »
mentalmente). In Cartesio e Locke il termine indica una qualunque idea riferibile a un
oggetto, reale o immaginario, e così anche in Berkeley e in Hume. Ma per i primi due
sorge il problema di come giustificare e garantire la corrispondenza della
rappresentazione con l’oggetto reale, problema che non sussiste ovviamente quando
l’oggetto dell’attività rappresentativa sia concepito come interno alla mente stessa.
Così Hume può affermare che le idee semplici, le quali rappresentano le impressioni
originarie, le riproducono sempre sia pure in forma meno vivace. Per Leibniz le
monadi sono dotate di forza rappresentativa e ciascuna di esse contiene in sé la
rappresentazione dell’universo. Hegel definisce la rappresentazione come « il
contenuto che viene offerto dall’esperienza » e la colloca a metà strada tra
l’intuizione empirica e il pensiero. Per Schopenhauer il mondo che ci si offre nelle
forme dello spazio, del tempo e della causalità è tutto rappresentazione, e la sua
realtà differisce da quella del sogno solo per il diverso grado di continuità e di
connessione. Croce infine usa di solito rappresentazione come equivalente di
intuizione.
RĀSA. Voce sanscrita che indica l’essenza del gusto, che costituisce una delle sei
regole (sadanga) dell’estetica indiana.
RAVAISSON-MOLLIEN (Félix LACHER), filosofo francese (Namur 1813 - Parigi
1900). Compì gli studi prima a Parigi poi a Monaco, dove seguì le lezioni di
Schelling. Nel 1837 raggiunse la notorietà con un Saggio sulla metafisica di
Aristotele, che fu pubblicato, con l’aggiunta di un secondo volume, nel 1846.
Addottoratosi nel 1838 con una celebre tesi sull’Abitudine*, dopo una prima
esperienza di insegnamento all’università di Rennes, per l’ostilità dell’onnipotente
V. Cousin dovette abbandonare il mondo accademico e ripiegare sulla carriera
burocratica, divenendo prima (1840) ispettore generale delle biblioteche e poi
ispettore generale dell’istruzione superiore (1859-1888).
Il pensiero di Ravaisson, che si svolge nell’ambito dello spiritualismo francese della
seconda metà dell’Ottocento, se da una parte si riallaccia direttamente
all’insegnamento di Maine de Biran, dall’altra, per le istanze vitalistiche in esso
contenute, anticipa alcuni dei temi fondamentali delle filosofie di Lachelier, di
Boutroux e di Bergson. Opere principali, oltre a quelle citate: Rapporto sullo
stoicismo (1851), Rapporto sulla filosofia in Francia nel XIX secolo (1868),
Morale e Metafisica (1893). Ravaisson coltivò altresì l’archeologia e pubblicò un
volume sulla Venere di Milo (1871).
Bibliogr.: In italiano sono disponibili: Saggi filosofici, a cura di A. Tilgher, Roma
1917; su R.: J. Dopp, F. Ravaisson-Mollien, Lovanio 1933; C. Valerio, Ravaisson-
Mollien e l’idealismo romantico in Francia, Napoli 1936; D. Janicaud, Une