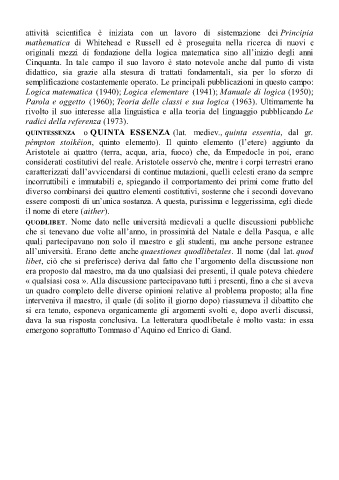Page 692 - Dizionario di Filosofia
P. 692
attività scientifica è iniziata con un lavoro di sistemazione dei Principia
mathematica di Whitehead e Russell ed è proseguita nella ricerca di nuovi e
originali mezzi di fondazione della logica matematica sino all’inizio degli anni
Cinquanta. In tale campo il suo lavoro è stato notevole anche dal punto di vista
didattico, sia grazie alla stesura di trattati fondamentali, sia per lo sforzo di
semplificazione costantemente operato. Le principali pubblicazioni in questo campo:
Logica matematica (1940); Logica elementare (1941); Manuale di logica (1950);
Parola e oggetto (1960); Teoria delle classi e sua logica (1963). Ultimamente ha
rivolto il suo interesse alla linguistica e alla teoria del linguaggio pubblicando Le
radici della referenza (1973).
QUINTESSENZA o QUINTA ESSENZA (lat. mediev., quinta essentia, dal gr.
pémpton stoikêion, quinto elemento). Il quinto elemento (l’etere) aggiunto da
Aristotele ai quattro (terra, acqua, aria, fuoco) che, da Empedocle in poi, erano
considerati costitutivi del reale. Aristotele osservò che, mentre i corpi terrestri erano
caratterizzati dall’avvicendarsi di continue mutazioni, quelli celesti erano da sempre
incorruttibili e immutabili e, spiegando il comportamento dei primi come frutto del
diverso combinarsi dei quattro elementi costitutivi, sostenne che i secondi dovevano
essere composti di un’unica sostanza. A questa, purissima e leggerissima, egli diede
il nome di etere (aither).
QUODLIBET. Nome dato nelle università medievali a quelle discussioni pubbliche
che si tenevano due volte all’anno, in prossimità del Natale e della Pasqua, e alle
quali partecipavano non solo il maestro e gli studenti, ma anche persone estranee
all’università. Erano dette anche quaestiones quodlibetales. Il nome (dal lat. quod
libet, ciò che si preferisce) deriva dal fatto che l’argomento della discussione non
era proposto dal maestro, ma da uno qualsiasi dei presenti, il quale poteva chiedere
« qualsiasi cosa ». Alla discussione partecipavano tutti i presenti, fino a che si aveva
un quadro completo delle diverse opinioni relative al problema proposto; alla fine
interveniva il maestro, il quale (di solito il giorno dopo) riassumeva il dibattito che
si era tenuto, esponeva organicamente gli argomenti svolti e, dopo averli discussi,
dava la sua risposta conclusiva. La letteratura quodlibetale è molto vasta: in essa
emergono soprattutto Tommaso d’Aquino ed Enrico di Gand.