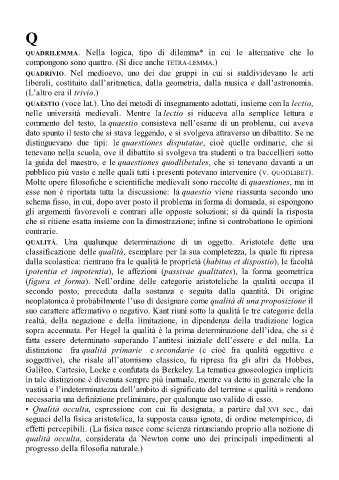Page 688 - Dizionario di Filosofia
P. 688
Q
QUADRILEMMA. Nella logica, tipo di dilemma* in cui le alternative che lo
compongono sono quattro. (Si dice anche TETRA-LEMMA.)
QUADRIVIO. Nel medioevo, uno dei due gruppi in cui si suddividevano le arti
liberali, costituito dall’aritmetica, dalla geometria, dalla musica e dall’astronomia.
(L’altro era il trivio.)
QUAESTIO (voce lat.). Uno dei metodi di insegnamento adottati, insieme con la lectio,
nelle università medievali. Mentre la lectio si riduceva alla semplice lettura e
commento del testo, la quaestio consisteva nell’esame di un problema, cui aveva
dato spunto il testo che si stava leggendo, e si svolgeva attraverso un dibattito. Se ne
distinguevano due tipi: le quaestiones disputatae, cioè quelle ordinarie, che si
tenevano nella scuola, ove il dibattito si svolgeva tra studenti o tra baccellieri sotto
la guida del maestro, e le quaestiones quodlibetales, che si tenevano davanti a un
pubblico più vasto e nelle quali tutti i presenti potevano intervenire (V. QUODLIBET).
Molte opere filosofiche e scientifiche medievali sono raccolte di quaestiones, ma in
esse non è riportata tutta la discussione: la quaestio viene riassunta secondo uno
schema fisso, in cui, dopo aver posto il problema in forma di domanda, si espongono
gli argomenti favorevoli e contrari alle opposte soluzioni; si dà quindi la risposta
che si ritiene esatta insieme con la dimostrazione; infine si controbattono le opinioni
contrarie.
QUALITÀ. Una qualunque determinazione di un oggetto. Aristotele dette una
classificazione delle qualità, esemplare per la sua completezza, la quale fu ripresa
dalla scolastica: rientrano fra le qualità le proprietà (habitus et dispostio), le facoltà
(potentia et impotentia), le affezioni (passivae qualitates), la forma geometrica
(figura et forma). Nell’ordine delle categorie aristoteliche la qualità occupa il
secondo posto, preceduta dalla sostanza e seguita dalla quantità. Di origine
neoplatonica è probabilmente l’uso di designare come qualità di una proposizione il
suo carattere affermativo o negativo. Kant riunì sotto la qualità le tre categorie della
realtà, della negazione e della limitazione, in dipendenza della tradizione logica
sopra accennata. Per Hegel la qualità è la prima determinazione dell’idea, che si è
fatta essere determinato superando l’antitesi iniziale dell’essere e del nulla. La
distinzione fra qualità primarie e secondarie (e cioè fra qualità oggettive e
soggettive), che risale all’atomismo classico, fu ripresa fra gli altri da Hobbes,
Galileo, Cartesio, Locke e confutata da Berkeley. La tematica gnoseologica implicita
in tale distinzione è divenuta sempre più inattuale, mentre va detto in generale che la
vastità e l’indeterminatezza dell’ambito di significato del termine « qualità » rendono
necessaria una definizione preliminare, per qualunque uso valido di esso.
• Qualità occulta, espressione con cui fu designata, a partire dal XVI sec., dai
seguaci della fisica aristotelica, la supposta causa ignota, di ordine metempirico, di
effetti percepibili. (La fisica nasce come scienza rinunciando proprio alla nozione di
qualità occulta, considerata da Newton come uno dei principali impedimenti al
progresso della filosofia naturale.)