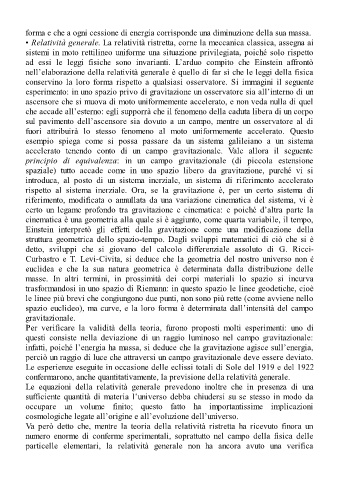Page 707 - Dizionario di Filosofia
P. 707
forma e che a ogni cessione di energia corrisponde una diminuzione della sua massa.
• Relatività generale. La relatività ristretta, corne la meccanica classica, assegna ai
sistemi in moto rettilineo uniforme una situazione privilegiata, poiché solo rispetto
ad essi le leggi fisiche sono invarianti. L’arduo compito che Einstein affrontò
nell’elaborazione della relatività generale è quello di far sì che le leggi della fisica
conservino la loro forma rispetto a qualsiasi osservatore. Si immagini il seguente
esperimento: in uno spazio privo di gravitazione un osservatore sia all’interno di un
ascensore che si muova di moto uniformemente accelerato, e non veda nulla di quel
che accade all’esterno: egli supporrà che il fenomeno della caduta libera di un corpo
sul pavimento dell’ascensore sia dovuto a un campo, mentre un osservatore al di
fuori attribuirà lo stesso fenomeno al moto uniformemente accelerato. Questo
esempio spiega come si possa passare da un sistema galileiano a un sistema
accelerato tenendo conto di un campo gravitazionale. Vale allora il seguente
principio di equivalenza: in un campo gravitazionale (di piccola estensione
spaziale) tutto accade come in uno spazio libero da gravitazione, purché vi si
introduca, al posto di un sistema inerziale, un sistema di riferimento accelerato
rispetto al sistema inerziale. Ora, se la gravitazione è, per un certo sistema di
riferimento, modificata o annullata da una variazione cinematica del sistema, vi è
certo un legame profondo tra gravitazione e cinematica: e poiché d’altra parte la
cinematica è una geometria alla quale si è aggiunto, come quarta variabile, il tempo,
Einstein interpretò gli effetti della gravitazione come una modificazione della
struttura geometrica dello spazio-tempo. Dagli sviluppi matematici di ciò che si è
detto, sviluppi che si giovano del calcolo differenziale assoluto di G. Ricci-
Curbastro e T. Levi-Civita, si deduce che la geometria del nostro universo non è
euclidea e che la sua natura geometrica è determinata dalla distribuzione delle
masse. In altri termini, in prossimità dei corpi materiali lo spazio si incurva
trasformandosi in uno spazio di Riemann: in questo spazio le linee geodetiche, cioè
le linee più brevi che congiungono due punti, non sono più rette (come avviene nello
spazio euclideo), ma curve, e la loro forma è determinata dall’intensità del campo
gravitazionale.
Per verificare la validità della teoria, furono proposti molti esperimenti: uno di
questi consiste nella deviazione di un raggio luminoso nel campo gravitazionale:
infatti, poiché l’energia ha massa, si deduce che la gravitazione agisce sull’energia,
perciò un raggio di luce che attraversi un campo gravitazionale deve essere deviato.
Le esperienze eseguite in occasione delle eclissi totali di Sole del 1919 e del 1922
confermarono, anche quantitativamente, la previsione della relatività generale.
Le equazioni della relatività generale prevedono inoltre che in presenza di una
sufficiente quantità di materia l’universo debba chiudersi su se stesso in modo da
occupare un volume finito; questo fatto ha importantissime implicazioni
cosmologiche legate all’origine e all’evoluzione dell’universo.
Va però detto che, mentre la teoria della relatività ristretta ha ricevuto finora un
numero enorme di conferme sperimentali, soprattutto nel campo della fisica delle
particelle elementari, la relatività generale non ha ancora avuto una verifica