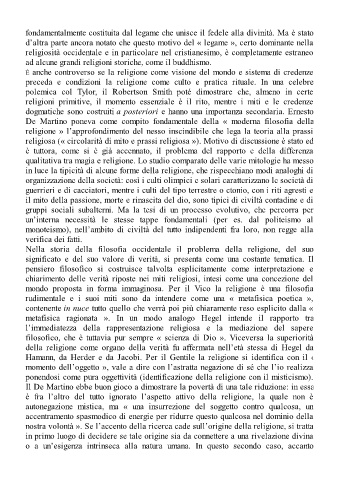Page 710 - Dizionario di Filosofia
P. 710
fondamentalmente costituita dal legame che unisce il fedele alla divinità. Ma è stato
d’altra parte ancora notato che questo motivo del « legame », certo dominante nella
religiosità occidentale e in particolare nel cristianesimo, è completamente estraneo
ad alcune grandi religioni storiche, come il buddhismo.
È anche controverso se la religione come visione del mondo e sistema di credenze
preceda e condizioni la religione come culto e pratica rituale. In una celebre
polemica col Tylor, il Robertson Smith poté dimostrare che, almeno in certe
religioni primitive, il momento essenziale è il rito, mentre i miti e le credenze
dogmatiche sono costruiti a posteriori e hanno una importanza secondaria. Ernesto
De Martino poneva come compito fondamentale della « moderna filosofia della
religione » l’approfondimento del nesso inscindibile che lega la teoria alla prassi
religiosa (« circolarità di mito e prassi religiosa »). Motivo di discussione è stato ed
è tuttora, come si è già accennato, il problema del rapporto e della differenza
qualitativa tra magia e religione. Lo studio comparato delle varie mitologie ha messo
in luce la tipicità di alcune forme della religione, che rispecchiano modi analoghi di
organizzazione della società: così i culti olimpici e solari caratterizzano le società di
guerrieri e di cacciatori, mentre i culti del tipo terrestre o ctonio, con i riti agresti e
il mito della passione, morte e rinascita del dio, sono tipici di civiltà contadine e di
gruppi sociali subalterni. Ma la tesi di un processo evolutivo, che percorra per
un’interna necessità le stesse tappe fondamentali (per es. dal politeismo al
monoteismo), nell’ambito di civiltà del tutto indipendenti fra loro, non regge alla
verifica dei fatti.
Nella storia della filosofia occidentale il problema della religione, del suo
significato e del suo valore di verità, si presenta come una costante tematica. Il
pensiero filosofico si costruisce talvolta esplicitamente come interpretazione e
chiarimento delle verità riposte nei miti religiosi, intesi come una concezione del
mondo proposta in forma immaginosa. Per il Vico la religione è una filosofia
rudimentale e i suoi miti sono da intendere come una « metafisica poetica »,
contenente in nuce tutto quello che verrà poi più chiaramente reso esplicito dalla «
metafisica ragionata ». In un modo analogo Hegel intende il rapporto tra
l’immediatezza della rappresentazione religiosa e la mediazione del sapere
filosofico, che è tuttavia pur sempre « scienza di Dio ». Viceversa la superiorità
della religione come organo della verità fu affermata nell’età stessa di Hegel da
Hamann, da Herder e da Jacobi. Per il Gentile la religione si identifica con il «
momento dell’oggetto », vale a dire con l’astratta negazione di sé che l’io realizza
ponendosi come pura oggettività (identificazione della religione con il misticismo).
Il De Martino ebbe buon gioco a dimostrare la povertà di una tale riduzione: in essa
è fra l’altro del tutto ignorato l’aspetto attivo della religione, la quale non è
autonegazione mistica, ma « una insurrezione del soggetto contro qualcosa, un
accentramento spasmodico di energie per ridurre questo qualcosa nel dominio della
nostra volontà ». Se l’accento della ricerca cade sull’origine della religione, si tratta
in primo luogo di decidere se tale origine sia da connettere a una rivelazione divina
o a un’esigenza intrinseca alla natura umana. In questo secondo caso, accanto