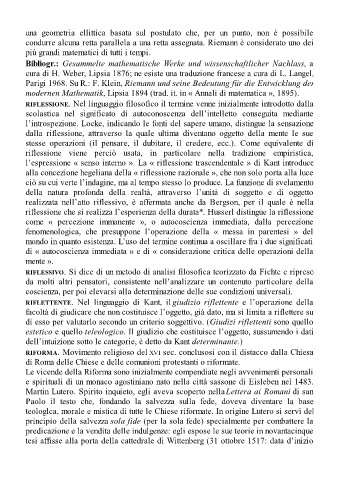Page 715 - Dizionario di Filosofia
P. 715
una geometria ellittica basata sul postulato che, per un punto, non è possibile
condurre alcuna retta parallela a una retta assegnata. Riemann è considerato uno dei
più grandi matematici di tutti i tempi.
Bibliogr.: Gesammelte mathematische Werke und wissenschaftlicher Nachlass, a
cura di H. Weber, Lipsia 1876; ne esiste una traduzione francese a cura di L. Langel,
Parigi 1968. Su R.: F. Klein, Riemann und seine Bedeutung für die Entwicklung der
modernen Mathematik, Lipsia 1894 (trad. it. in « Annali di matematica », 1895).
RIFLESSIONE. Nel linguaggio filosofico il termine venne inizialmente introdotto dalla
scolastica nel significato di autoconoscenza dell’intelletto conseguita mediante
l’introspezione. Locke, indicando le fonti del sapere umano, distingue la sensazione
dalla riflessione, attraverso la quale ultima diventano oggetto della mente le sue
stesse operazioni (il pensare, il dubitare, il credere, ecc.). Come equivalente di
riflessione viene perciò usata, in particolare nella tradizione empiristica,
l’espressione « senso interno ». La « riflessione trascendentale » di Kant introduce
alla concezione hegeliana della « riflessione razionale », che non solo porta alla luce
ciò su cui verte l’indagine, ma al tempo stesso lo produce. La funzione di svelamento
della natura profonda della realtà, attraverso l’unità di soggetto e di oggetto
realizzata nell’atto riflessivo, è affermata anche da Bergson, per il quale è nella
riflessione che si realizza l’esperienza della durata*. Husserl distingue la riflessione
come « percezione immanente », o autocoscienza immediata, dalla percezione
fenomenologica, che presuppone l’operazione della « messa in parentesi » del
mondo in quanto esistenza. L’uso del termine continua a oscillare fra i due significati
di « autocoscienza immediata » e di « considerazione critica delle operazioni della
mente ».
RIFLESSIVO. Si dice di un metodo di analisi filosofica teorizzato da Fichte e ripreso
da molti altri pensatori, consistente nell’analizzare un contenuto particolare della
coscienza, per poi elevarsi alla determinazione delle sue condizioni universali.
RIFLETTENTE. Nel linguaggio di Kant, il giudizio riflettente e l’operazione della
facoltà di giudicare che non costituisce l’oggetto, già dato, ma si limita a riflettere su
di esso per valutarlo secondo un criterio soggettivo. (Giudizi riflettenti sono quello
estetico e quello teleologico. Il giudizio che costituisce l’oggetto, sussumendo i dati
dell’intuizione sotto le categorie, è detto da Kant determinante.)
RIFORMA. Movimento religioso del XVI sec. conclusosi con il distacco dalla Chiesa
di Roma delle Chiese e delle comunioni protestanti o riformate.
Le vicende della Riforma sono inizialmente compendiate negli avvenimenti personali
e spirituali di un monaco agostiniano nato nella città sassone di Eisleben nel 1483.
Martin Lutero. Spirito inquieto, egli aveva scoperto nella Lettera ai Romani di san
Paolo il testo che, fondando la salvezza sulla fede, doveva diventare la base
teologlca, morale e mistica di tutte le Chiese riformate. In origine Lutero si servì del
principio della salvezza sola fide (per la sola fede) specialmente per combattere la
predicazione e la vendita delle indulgenze: egli espose le sue teorie in novantacinque
tesi affisse alla porta della cattedrale di Wittenberg (31 ottobre 1517: data d’inizio