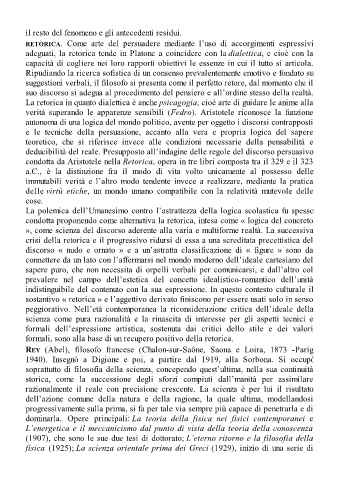Page 713 - Dizionario di Filosofia
P. 713
il resto del fenomeno e gli antecedenti residui.
RETÒRICA. Come arte del persuadere mediante l’uso di accorgimenti espressivi
adeguati, la retorica tende in Platone a coincidere con la dialettica, e cioè con la
capacità di cogliere nei loro rapporti obiettivi le essenze in cui il tutto si articola.
Ripudiando la ricerca sofistica di un consenso prevalentemente emotivo e fondato su
suggestioni verbali, il filosofo si presenta come il perfetto retore, dal momento che il
suo discorso si adegua al procedimento del pensiero e all’ordine stesso della realtà.
La retorica in quanto dialettica è anche psicagogia, cioè arte di guidare le anime alla
verità superando le apparenze sensibili (Fedro). Aristotele riconosce la funzione
autonoma di una logica del mondo politico, avente per oggetto i discorsi contrapposti
e le tecniche della persuasione, accanto alla vera e propria logica del sapere
teoretico, che si riferisce invece alle condizioni necessarie della pensabilità e
deducibilità del reale. Presupposto all’indagine delle regole del discorso persuasivo
condotta da Aristotele nella Retorica, opera in tre libri composta tra il 329 e il 323
a.C., è la distinzione fra il modo di vita volto unicamente al possesso delle
immutabili verità e l’altro modo tendente invece a realizzare, mediante la pratica
delle virtù etiche, un mondo umano compatibile con la relatività mutevole delle
cose.
La polemica dell’Umanesimo contro l’astrattezza della logica scolastica fu spesso
condotta proponendo come alternativa la retorica, intesa come « logica del concreto
», come scienza del discorso aderente alla varia e multiforme realtà. La successiva
crisi della retorica e il progressivo ridursi di essa a una screditata precettistica del
discorso « nudo e ornato » e a un’astratta classificazione di « figure » sono da
connettere da un lato con l’affermarsi nel mondo moderno dell’ideale cartesiano del
sapere puro, che non necessita di orpelli verbali per comunicarsi, e dall’altro col
prevalere nel campo dell’estetica del concetto idealistico-romantico dell’unità
indistinguibile del contenuto con la sua espressione. In questo contesto culturale il
sostantivo « retorica » e l’aggettivo derivato finiscono per essere usati solo in senso
peggiorativo. Nell’età contemporanea la riconsiderazione critica dell’ideale della
scienza come pura razionalità e la rinascita di interesse per gli aspetti tecnici e
formali dell’espressione artistica, sostenuta dai critici dello stile e dei valori
formali, sono alla base di un recupero positivo della retorica.
REY (Abel), filosofo francese (Chalon-sur-Saône, Saona e Loira, 1873 -Parigi
1940). Insegnò a Digione e poi, a partire dal 1919, alla Sorbona. Si occupò
soprattutto di filosofia della scienza, concependo quest’ultima, nella sua continuità
storica, come la successione degli sforzi compiuti dall’manità per assimilare
razionalmente il reale con precisione crescente. La scienza è per lui il risultato
dell’azione comune della natura e della ragione, la quale ultima, modellandosi
progressivamente sulla prima, si fa per tale via sempre più capace di penetrarla e di
dominarla. Opere principali: La teoria della fisica nei fisici contemporanei e
L’energetica e il meccanicismo dal punto di vista della teoria della conoscenza
(1907), che sono le sue due tesi di dottorato; L’eterno ritorno e la filosofia della
fisica (1925); La scienza orientale prima dei Greci (1929), inizio di una serie di