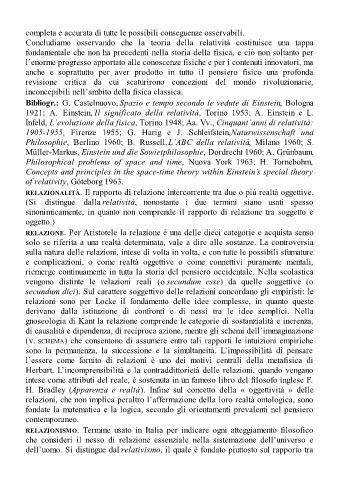Page 708 - Dizionario di Filosofia
P. 708
completa e accurata di tutte le possibili conseguenze osservabili.
Concludiamo osservando che la teoria della relatività costituisce una tappa
fondamentale che non ha precedenti nella storia della fisica, e ciò non soltanto per
l’enorme progresso apportato alle conoscenze fisiche e per i contenuti innovatori, ma
anche e soprattutto per aver prodotto in tutto il pensiero fisico una profonda
revisione critica da cui scaturirono concezioni del mondo rivoluzionarie,
inconcepibili nell’ambito della fisica classica.
Bibliogr.: G. Castelnuovo, Spazio e tempo secondo le vedute di Einstein, Bologna
1921; A. Einstein, Il significato della relatività, Torino 1953; A. Einstein e L.
Infeld, L’evoluzione della fisica, Torino 1948; Aa. Vv., Cinquant’anni di relatività:
1905-1955, Firenze 1955; G. Harig e J. Schleifstein, Naturwissenschaft und
Philosophie, Berlino 1960; B. Russell, L’ABC della relatività, Milano 1960; S.
Müller-Markus, Einstein und die Sowietphilosophie, Dordrecht 1960; A. Grünbaum,
Philosophical problems of space and time, Nuova York 1963; H. Tornebohm,
Concepts and principles in the space-time theory within Einstein’s special theory
of relativity, Göteborg 1963.
RELAZIONALITÀ. Il rapporto di relazione intercorrente tra due o più realtà oggettive.
(Si distingue dalla relatività, nonostante i due termini siano usati spesso
sinonimicamente, in quanto non comprende il rapporto di relazione tra soggetto e
oggetto.)
RELAZIONE. Per Aristotele la relazione è una delle dieci categorie e acquista senso
solo se riferita a una realtà determinata, vale a dire alle sostanze. La controversia
sulla natura delle relazioni, intese di volta in volta, e con tutte le possibili sfumature
e complicazioni, o come realtà oggettive o come connettivi puramente mentali,
riemerge continuamente in tutta la storia del pensiero occidentale. Nella scolastica
vengono distinte le relazioni reali (o secundum esse) da quelle soggettive (o
secundum dici). Sul carattere soggettivo delle relazioni concordano gli empiristi: le
relazioni sono per Locke il fondamento delle idee complesse, in quanto queste
derivano dalla istituzione di confronti e di nessi tra le idee semplici. Nella
gnoseologia di Kant la relazione comprende le categorie di sostanzialità e inerenza,
di causalità e dipendenza, di reciproca azione, mentre gli schemi dell’immaginazione
(v. SCHEMA) che consentono di assumere entro tali rapporti le intuizioni empiriche
sono la permanenza, la successione e la simultaneità. L’impossibilità di pensare
l’essere come fornito di relazioni è uno dei motivi centrali della metafisica di
Herbart. L’incomprensibilità e la contraddittorietà delle relazioni, quando vengano
intese come attributi del reale, è sostenuta in un famoso libro del filosofo inglese F.
H. Bradley (Apparenza e realtà). Infine sul concetto della « oggettività » delle
relazioni, che non implica peraltro l’affermazione della loro realtà ontologica, sono
fondate la matematica e la logica, secondo gli orientamenti prevalenti nel pensiero
contemporaneo.
RELAZIONISMO. Termine usato in Italia per indicare ogni atteggiamento filosofico
che consideri il nesso di relazione essenziale nella sistemazione dell’universo e
dell’uomo. Si distingue dal relativismo, il quale è fondato piuttosto sul rapporto tra