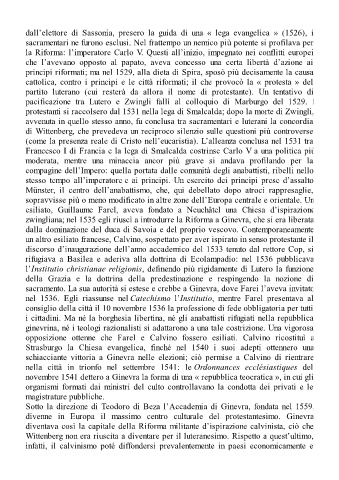Page 717 - Dizionario di Filosofia
P. 717
dall’elettore di Sassonia, presero la guida di una « lega evangelica » (1526), i
sacramentari ne furono esclusi. Nel frattempo un nemico più potente si profilava per
la Riforma: l’imperatore Carlo V. Questi all’inizio, impegnato nei conflitti europei
che l’avevano opposto al papato, aveva concesso una certa libertà d’azione ai
principi riformati; ma nel 1529, alla dieta di Spira, sposò più decisamente la causa
cattolica, contro i principi e le città riformati; il che provocò la « protesta » del
partito luterano (cui resterà da allora il nome di protestante). Un tentativo di
pacificazione tra Lutero e Zwingli fallì al colloquio di Marburgo del 1529. I
protestanti si raccolsero dal 1531 nella lega di Smalcalda; dopo la morte di Zwingli,
avvenuta in quello stesso anno, fu conclusa tra sacramentari e luterani la concordia
di Wittenberg, che prevedeva un reciproco silenzio sulle questioni più controverse
(come la presenza reale di Cristo nell’eucaristia). L’alleanza conclusa nel 1531 tra
Francesco I di Francia e la lega di Smalcalda costrinse Carlo V a una politica più
moderata, mentre una minaccia ancor più grave si andava profilando per la
compagine dell’Impero: quella portata dalle comunità degli anabattisti, ribelli nello
stesso tempo all’imperatore e ai principi. Un esercito dei principi prese d’assalto
Münster, il centro dell’anabattismo, che, qui debellato dopo atroci rappresaglie,
sopravvisse più o meno modificato in altre zone dell’Europa centrale e orientale. Un
esiliato, Guillaume Farel, aveva fondato a Neuchâtel una Chiesa d’ispirazione
zwingliana; nel 1535 egli riuscì a introdurre la Riforma a Ginevra, che si era liberata
dalla dominazione del duca di Savoia e del proprio vescovo. Contemporaneamente
un altro esiliato francese, Calvino, sospettato per aver ispirato in senso protestante il
discorso d’inaugurazione dell’anno accademico del 1533 tenuto dal rettore Cop, si
rifugiava a Basilea e aderiva alla dottrina di Ecolampadio: nel 1536 pubblicava
l’Institutio christianae religionis, definendo più rigidamente di Lutero la funzione
della Grazia e la dottrina della predestinazione e respingendo la nozione di
sacramento. La sua autorità si estese e crebbe a Ginevra, dove Farei l’aveva invitato
nel 1536. Egli riassunse nel Catechismo l’Institutio, mentre Farel presentava al
consiglio della città il 10 novembre 1536 la professione di fede obbligatoria per tutti
i cittadini. Ma né la borghesia libertina, né gli anabattisti rifugiati nella repubblica
ginevrina, né i teologi razionalisti si adattarono a una tale costrizione. Una vigorosa
opposizione ottenne che Farel e Calvino fossero esiliati. Calvino ricostituì a
Strasburgo la Chiesa evangelica, finché nel 1540 i suoi adepti ottennero una
schiacciante vittoria a Ginevra nelle elezioni; ciò permise a Calvino di rientrare
nella città in trionfo nel settembre 1541: le Ordonnances ecclésiastiques del
novembre 1541 dettero a Ginevra la forma di una « repubblica teocratica », in cui gli
organismi formati dai ministri del culto controllavano la condotta dei privati e le
magistrature pubbliche.
Sotto la direzione di Teodoro di Beza l’Accademia di Ginevra, fondata nel 1559,
divenne in Europa il massimo centro culturale del protestantesimo. Ginevra
diventava così la capitale della Riforma militante d’ispirazione calvinista, ciò che
Wittenberg non era riuscita a diventare per il luteranesimo. Rispetto a quest’ultimo,
infatti, il calvinismo poté diffondersi prevalentemente in paesi economicamente e