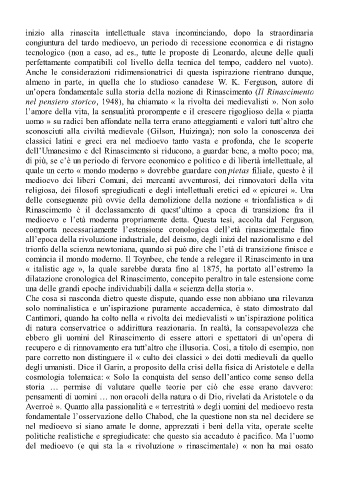Page 720 - Dizionario di Filosofia
P. 720
inizio alla rinascita intellettuale stava incominciando, dopo la straordinaria
congiuntura del tardo medioevo, un periodo di recessione economica e di ristagno
tecnologico (non a caso, ad es., tutte le proposte di Leonardo, alcune delle quali
perfettamente compatibili col livello della tecnica del tempo, caddero nel vuoto).
Anche le considerazioni ridimensionatrici di questa ispirazione rientrano dunque,
almeno in parte, in quella che lo studioso canadese W. K. Ferguson, autore di
un’opera fondamentale sulla storia della nozione di Rinascimento (Il Rinascimento
nel pensiero storico, 1948), ha chiamato « la rivolta dei medievalisti ». Non solo
l’amore della vita, la sensualità prorompente e il crescere rigoglioso della « pianta
uomo » su radici ben affondate nella terra erano atteggiamenti e valori tutt’altro che
sconosciuti alla civiltà medievale (Gilson, Huizinga); non solo la conoscenza dei
classici latini e greci era nel medioevo tanto vasta e profonda, che le scoperte
dell’Umanesimo e del Rinascimento si riducono, a guardar bene, a molto poco; ma,
di più, se c’è un periodo di fervore economico e politico e di libertà intellettuale, al
quale un certo « mondo moderno » dovrebbe guardare con pietas filiale, questo è il
medioevo dei liberi Comuni, dei mercanti avventurosi, dei rinnovatori della vita
religiosa, dei filosofi spregiudicati e degli intellettuali eretici ed « epicurei ». Una
delle conseguenze più ovvie della demolizione della nozione « trionfalistica » di
Rinascimento è il declassamento di quest’ultimo a epoca di transizione fra il
medioevo e l’età moderna propriamente detta. Questa tesi, accolta dal Ferguson,
comporta necessariamente l’estensione cronologica dell’età rinascimentale fino
all’epoca della rivoluzione industriale, del deismo, degli inizi del nazionalismo e del
trionfo della scienza newtoniana, quando si può dire che l’età di transizione finisce e
comincia il mondo moderno. Il Toynbee, che tende a relegare il Rinascimento in una
« italistic age », la quale sarebbe durata fino al 1875, ha portato all’estremo la
dilatazione cronologica del Rinascimento, concepito peraltro in tale estensione come
una delle grandi epoche individuabili dalla « scienza della storia ».
Che cosa si nasconda dietro queste dispute, quando esse non abbiano una rilevanza
solo nominalistica e un’ispirazione puramente accademica, è stato dimostrato dal
Cantimori, quando ha colto nella « rivolta dei medievalisti » un’ispirazione politica
di natura conservatrice o addirittura reazionaria. In realtà, la consapevolezza che
ebbero gli uomini del Rinascimento di essere attori e spettatori di un’opera di
recupero e di rinnovamento era tutt’altro che illusoria. Così, a titolo di esempio, non
pare corretto non distinguere il « culto dei classici » dei dotti medievali da quello
degli umanisti. Dice il Garin, a proposito della crisi della fisica di Aristotele e della
cosmologia tolemaica: « Solo la conquista del senso dell’antico come senso della
storia … permise di valutare quelle teorie per ciò che esse erano davvero:
pensamenti di uomini … non oracoli della natura o di Dio, rivelati da Aristotele o da
Averroè ». Quanto alla passionalità e « terrestrità » degli uomini del medioevo resta
fondamentale l’osservazione dello Chabod, che la questione non sta nel decidere se
nel medioevo si siano amate le donne, apprezzati i beni della vita, operate scelte
politiche realistiche e spregiudicate: che questo sia accaduto è pacifico. Ma l’uomo
del medioevo (e qui sta la « rivoluzione » rinascimentale) « non ha mai osato