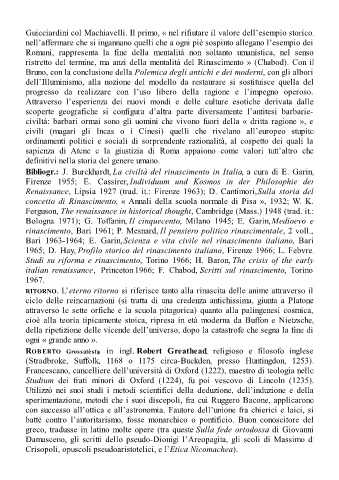Page 722 - Dizionario di Filosofia
P. 722
Guicciardini col Machiavelli. Il primo, « nel rifiutare il valore dell’esempio storico,
nell’affermare che si ingannano quelli che a ogni piè sospinto allegano l’esempio dei
Romani, rappresenta la fine della mentalità non soltanto umanistica, nel senso
ristretto del termine, ma anzi della mentalità del Rinascimento » (Chabod). Con il
Bruno, con la conclusione della Polemica degli antichi e dei moderni, con gli albori
dell’Illuminismo, alla nozione del modello da restaurare si sostituisce quella del
progresso da realizzare con l’uso libero della ragione e l’impegno operoso.
Attraverso l’esperienza dei nuovi mondi e delle culture esotiche derivata dalle
scoperte geografiche si configura d’altra parte diversamente l’antitesi barbarie-
civiltà: barbari ormai sono gli uomini che vivono fuori della « dritta ragione », e
civili (magari gli Incas o i Cinesi) quelli che rivelano all’europeo stupito
ordinamenti politici e sociali di sorprendente razionalità, al cospetto dei quali la
sapienza di Atene e la giustizia di Roma appaiono come valori tutt’altro che
definitivi nella storia del genere umano.
Bibliogr.: J. Burckhardt, La civiltà del rinascimento in Italia, a cura di E. Garin,
Firenze 1955; E. Cassirer, Individuum und Kosmos in der Philosophie der
Renaissance, Lipsia 1927 (trad. it.: Firenze 1963); D. Cantimori, Sulla storia del
concetto di Rinascimento, « Annali della scuola normale di Pisa », 1932; W. K.
Ferguson, The renaissance in historical thought, Cambridge (Mass.) 1948 (trad. it.:
Bologna 1971); G. Toffanin, Il cinquecento, Milano 1945; E. Garin, Medioevo e
rinascimento, Bari 1961; P. Mesnard, Il pensiero politico rinascimentale, 2 voll.,
Bari 1963-1964; E. Garin, Scienza e vita civile nel rinascimento italiano, Bari
1965; D. Hay, Profilo storico del rinascimento italiano, Firenze 1966; L. Febvre,
Studi su riforma e rinascimento, Torino 1966; H. Baron, The crisis of the early
italian renaissance, Princeton 1966; F. Chabod, Scritti sul rinascimento, Torino
1967.
RITORNO. L’eterno ritorno si riferisce tanto alla rinascita delle anime attraverso il
ciclo delle reincarnazioni (si tratta di una credenza antichissima, giunta a Platone
attraverso le sette orfiche e la scuola pitagorica) quanto alla palingenesi cosmica,
cioè alla teoria tipicamente stoica, ripresa in età moderna da Buffon e Nietzsche,
della ripetizione delle vicende dell’universo, dopo la catastrofe che segna la fine di
ogni « grande anno ».
ROBERTO Grossatèsta, in ingl. Robert Greathead, religioso e filosofo inglese
(Stradbroke, Suffolk, 1168 o 1175 circa-Buckden, presso Huntingdon, 1253).
Francescano, cancelliere dell’università di Oxford (1222), maestro di teologia nello
Studium dei frati minori di Oxford (1224), fu poi vescovo di Lincoln (1235).
Utilizzò nei suoi studi i metodi scientifici della deduzione, dell’induzione e della
sperimentazione, metodi che i suoi discepoli, fra cui Ruggero Bacone, applicarono
con successo all’ottica e all’astronomia. Fautore dell’unione fra chierici e laici, si
batté contro l’autoritarismo, fosse monarchico o pontificio. Buon conoscitore del
greco, tradusse in latino molte opere (tra queste Sulla fede ortodossa di Giovanni
Damasceno, gli scritti dello pseudo-Dionigi l’Areopagita, gli scoli di Massimo di
Crisopoli, opuscoli pseudoaristotelici, e l’Etica Nicomachea).