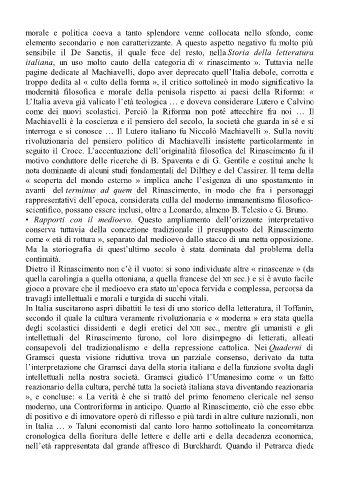Page 719 - Dizionario di Filosofia
P. 719
morale e politica coeva a tanto splendore venne collocata nello sfondo, come
elemento secondario e non caratterizzante. A questo aspetto negativo fu molto più
sensibile il De Sanctis, il quale fece del resto, nella Storia della letteratura
italiana, un uso molto cauto della categoria di « rinascimento ». Tuttavia nelle
pagine dedicate al Machiavelli, dopo aver deprecato quell’Italia debole, corrotta e
troppo dedita al « culto della forma », il critico sottolineò in modo significativo la
modernità filosofica e morale della penisola rispetto ai paesi della Riforma: «
L’Italia aveva già valicato l’età teologica … e doveva considerare Lutero e Calvino
come dei nuovi scolastici. Perciò la Riforma non poté attecchire fra noi … Il
Machiavelli è la coscienza e il pensiero del secolo, la società che guarda in sé e si
interroga e si conosce … Il Lutero italiano fu Niccolò Machiavelli ». Sulla novità
rivoluzionaria del pensiero politico di Machiavelli insistette particolarmente in
seguito il Croce. L’accentuazione dell’originalità filosofica del Rinascimento fu il
motivo conduttore delle ricerche di B. Spaventa e di G. Gentile e costituì anche la
nota dominante di alcuni studi fondamentali del Dilthey e del Cassirer. Il tema della
« scoperta del mondo esterno » implica anche l’esigenza di uno spostamento in
avanti del terminus ad quem del Rinascimento, in modo che fra i personaggi
rappresentativi dell’epoca, considerata culla del moderno immanentismo filosofico-
scientifico, possano essere inclusi, oltre a Leonardo, almeno B. Telesio e G. Bruno.
• Rapporti con il medioevo. Questo ampliamento dell’orizzonte interpretativo
conserva tuttavia della concezione tradizionale il presupposto del Rinascimento
come « età di rottura », separato dal medioevo dallo stacco di una netta opposizione.
Ma la storiografìa di quest’ultimo secolo è stata dominata dal problema della
continuità.
Dietro il Rinascimento non c’è il vuoto: si sono individuate altre « rinascenze » (da
quella carolingia a quella ottoniana, a quella francese del XII sec.) e si è avuto facile
gioco a provare che il medioevo era stato un’epoca fervida e complessa, percorsa da
travagli intellettuali e morali e turgida di succhi vitali.
In Italia suscitarono aspri dibattiti le tesi di uno storico della letteratura, il Toffanin,
secondo il quale la cultura veramente rivoluzionaria e « moderna » era stata quella
degli scolastici dissidenti e degli eretici del XIII sec., mentre gli umanisti e gli
intellettuali del Rinascimento furono, col loro disimpegno di letterati, alleati
consapevoli del tradizionalismo e della repressione cattolica. Nei Quaderni di
Gramsci questa visione riduttiva trova un parziale consenso, derivato da tutta
l’interpretazione che Gramsci dava della storia italiana e della funzione svolta dagli
intellettuali nella nostra società. Gramsci giudicò l’Umanesimo come « un fatto
reazionario della cultura, perché tutta la società italiana stava diventando reazionaria
», e concluse: « La verità è che si trattò del primo fenomeno clericale nel senso
moderno, una Controriforma in anticipo. Quanto al Rinascimento, ciò che esso ebbe
di positivo e di innovatore operò di riflesso e più tardi in altre culture nazionali, non
in Italia … » Taluni economisti dal canto loro hanno sottolineato la concomitanza
cronologica della fioritura delle lettere e delle arti e della decadenza economica,
nell’età rappresentata dal grande affresco di Burckhardt. Quando il Petrarca diede