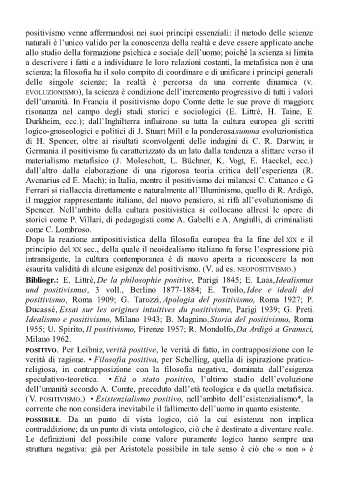Page 665 - Dizionario di Filosofia
P. 665
positivismo venne affermandosi nei suoi principi essenziali: il metodo delle scienze
naturali è l’unico valido per la conoscenza della realtà e deve essere applicato anche
allo studio della formazione psichica e sociale dell’uomo; poiché la scienza si limita
a descrivere i fatti e a individuare le loro relazioni costanti, la metafisica non è una
scienza; la filosofia ha il solo compito di coordinare e di unificare i principi generali
delle singole scienze; la realtà è percorsa da una corrente dinamica (v.
EVOLUZIONISMO), la scienza è condizione dell’incremento progressivo di tutti i valori
dell’umanità. In Francia il positivismo dopo Comte dette le sue prove di maggiore
risonanza nel campo degli studi storici e sociologici (E. Littré, H. Taine, E.
Durkheim, ecc.); dall’Inghilterra influirono su tutta la cultura europea gli scritti
logico-gnoseologici e politici di J. Stuart Mill e la ponderosa summa evoluzionistica
di H. Spencer, oltre ai risultati sconvolgenti delle indagini di C. R. Darwin; in
Germania il positivismo fu caratterizzato da un lato dalla tendenza a slittare verso il
materialismo metafisico (J. Moleschott, L. Büchner, K. Vogt, E. Haeckel, ecc.),
dall’altro dalla elaborazione di una rigorosa teoria critica dell’esperienza (R.
Avenarius ed E. Mach); in Italia, mentre il positivismo dei milanesi C. Cattaneo e G.
Ferrari si riallaccia direttamente e naturalmente all’Illuminismo, quello di R. Ardigò,
il maggior rappresentante italiano, del nuovo pensiero, si rifà all’evoluzionismo di
Spencer. Nell’ambito della cultura positivistica si collocano allresì le opere di
storici come P. Villari, di pedagogisti come A. Gabelli e A. Angiulli, di criminalisti
come C. Lombroso.
Dopo la reazione antipositivistica della filosofia europea fra la fine del XIX e il
principio del XX sec., della quale il neoidealismo italiano fu forse l’espressione più
intransigente, la cultura contemporanea è di nuovo aperta a riconoscere la non
esaurita validità di alcune esigenze del positivismo. (V. ad es. NEOPOSITIVISMO.)
Bibliogr.: E. Littré, De la philosophie positive, Parigi 1845; E. Laas, Idealismus
und positivismus, 3 voll., Berlino 1877-1884; E. Troilo, Idee e ideali del
positivismo, Roma 1909; G. Tarozzi, Apologia del positivismo, Roma 1927; P.
Ducassé, Essai sur les origines intuitives du positivisme, Parigi 1939; G. Preti,
Idealismo e positivismo, Milano 1943; B. Magnino, Storia del positivismo, Roma
1955; U. Spirito, Il positivismo, Firenze 1957; R. Mondolfo, Da Ardigò a Gramsci,
Milano 1962.
POSITIVO. Per Leibniz, verità positive, le verità di fatto, in contrapposizione con le
verità di ragione. • Filosofia positiva, per Schelling, quella di ispirazione pratico-
religiosa, in contrapposizione con la filosofia negativa, dominata dall’esigenza
speculativo-teoretica. • Età o stato positivo, l’ultimo stadio dell’evoluzione
dell’umanità secondo A. Comte, preceduto dall’età teologica e da quella metafisica.
(V. POSITIVISMO.) • Esistenzialismo positivo, nell’ambito dell’esistenzialismo*, la
corrente che non considera inevitabile il fallimento dell’uomo in quanto esistente.
POSSIBILE. Da un punto di vista logico, ciò la cui esistenza non implica
contraddizione; da un punto di vista ontologico, ciò che è destinato a diventare reale.
Le definizioni del possibile come valore puramente logico hanno sempre una
struttura negativa: già per Aristotele possibile in tale senso è ciò che « non » è