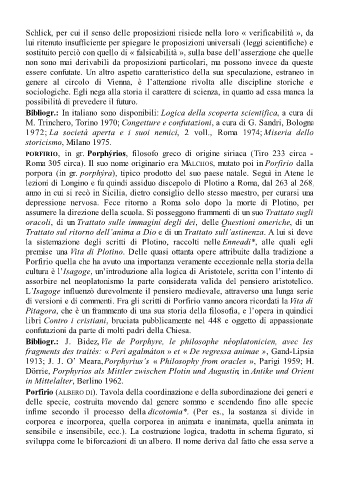Page 661 - Dizionario di Filosofia
P. 661
Schlick, per cui il senso delle proposizioni risiede nella loro « verificabilità », da
lui ritenuto insufficiente per spiegare le proposizioni universali (leggi scientifiche) e
sostituito perciò con quello di « falsicabilità », sulla base dell’asserzione che quelle
non sono mai derivabili da proposizioni particolari, ma possono invece da queste
essere confutate. Un altro aspetto caratteristico della sua speculazione, estraneo in
genere al circolo di Vienna, è l’attenzione rivolta alle discipline storiche e
sociologiche. Egli nega alla storia il carattere di scienza, in quanto ad essa manca la
possibilità di prevedere il futuro.
Bibliogr.: In italiano sono disponibili: Logica della scoperta scientifica, a cura di
M. Trinchero, Torino 1970; Congetture e confutazioni, a cura di G. Sandri, Bologna
1972; La società aperta e i suoi nemici, 2 voll., Roma 1974; Miseria dello
storicismo, Milano 1975.
PORFIRIO, in gr. Porphýrios, filosofo greco di origine siriaca (Tiro 233 circa -
Roma 305 circa). Il suo nome originario era MÀLCHOS, mutato poi in Porfirio dalla
porpora (in gr. porphýra), tipico prodotto del suo paese natale. Seguì in Atene le
lezioni di Longino e fu quindi assiduo discepolo di Plotino a Roma, dal 263 al 268,
anno in cui si recò in Sicilia, dietro consiglio dello stesso maestro, per curarsi una
depressione nervosa. Fece ritorno a Roma solo dopo la morte di Plotino, per
assumere la direzione della scuola. Si posseggono frammenti di un suo Trattato sugli
oracoli, di un Trattato sulle immagini degli dei, delle Questioni omeriche, di un
Trattato sul ritorno dell’anima a Dio e di un Trattato sull’astinenza. A lui si deve
la sistemazione degli scritti di Plotino, raccolti nelle Enneadi*, alle quali egli
premise una Vita di Plotino. Delle quasi ottanta opere attribuite dalla tradizione a
Porfirio quella che ha avuto una importanza veramente eccezionale nella storia della
cultura è l’Isagoge, un’introduzione alla logica di Aristotele, scritta con l’intento di
assorbire nel neoplatonismo la parte considerata valida del pensiero aristotelico.
L’Isagoge influenzò durevolmente il pensiero medievale, attraverso una lunga serie
di versioni e di commenti. Fra gli scritti di Porfirio vanno ancora ricordati la Vita di
Pitagora, che è un frammento di una sua storia della filosofia, e l’opera in quindici
libri Contro i cristiani, bruciata pubblicamente nel 448 e oggetto di appassionate
confutazioni da parte di molti padri della Chiesa.
Bibliogr.: J. Bidez, Vie de Porphyre, le philosophe néoplatonicien, avec les
fragments des traités: « Perì agalmáton » et « De regressa animae », Gand-Lipsia
1913; J. J. O’ Meara, Porphyrius’s « Philosophy from oracles », Parigi 1959; H.
Dörrie, Porphyrios als Mittler zwischen Plotin und Augustin, in Antike und Orient
in Mittelalter, Berlino 1962.
Porfirio (ALBERO DI). Tavola della coordinazione e della subordinazione dei generi e
delle specie, costruita movendo dal genere sommo e scendendo fino alle specie
infime secondo il processo della dicotomia*. (Per es., la sostanza si divide in
corporea e incorporea, quella corporea in animata e inanimata, quella animata in
sensibile e insensibile, ecc.). La costruzione logica, tradotta in schema figurato, si
sviluppa come le biforcazioni di un albero. Il nome deriva dal fatto che essa serve a