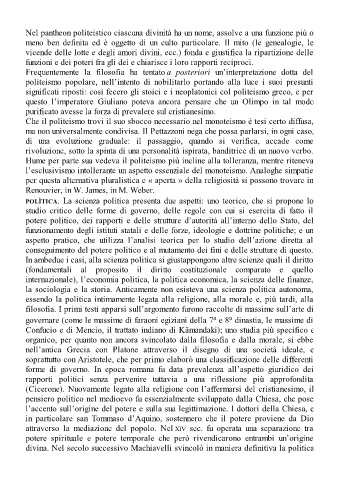Page 658 - Dizionario di Filosofia
P. 658
Nel pantheon politeistico ciascuna divinità ha un nome, assolve a una funzione più o
meno ben definita ed è oggetto di un culto particolare. Il mito (le genealogie, le
vicende delle lotte e degli amori divini, ecc.) fonda e giustifica la ripartizione delle
funzioni e dei poteri fra gli dei e chiarisce i loro rapporti reciproci.
Frequentemente la filosofia ha tentato a posteriori un’interpretazione dotta del
politeismo popolare, nell’intento di nobilitarlo portando alla luce i suoi presunti
significati riposti: così fecero gli stoici e i neoplatonici col politeismo greco, e per
questo l’imperatore Giuliano poteva ancora pensare che un Olimpo in tal modo
purificato avesse la forza di prevalere sul cristianesimo.
Che il politeismo trovi il suo sbocco necessario nel monoteismo è tesi certo diffusa,
ma non universalmente condivisa. Il Pettazzoni nega che possa parlarsi, in ogni caso,
di una evoluzione graduale: il passaggio, quando si verifica, accade come
rivoluzione, sotto la spinta di una personalità ispirata, banditrice di un nuovo verbo.
Hume per parte sua vedeva il politeismo più incline alla tolleranza, mentre riteneva
l’esclusivismo intollerante un aspetto essenziale del monoteismo. Analoghe simpatie
per questa alternativa pluralistica e « aperta » della religiosità si possono trovare in
Renouvier, in W. James, in M. Weber.
POLÌTICA. La scienza politica presenta due aspetti: uno teorico, che si propone lo
studio critico delle forme di governo, delle regole con cui si esercita di fatto il
potere politico, dei rapporti e delle strutture d’autorità all’interno dello Stato, del
funzionamento degli istituti statali e delle forze, ideologie e dottrine politiche; e un
aspetto pratico, che utilizza l’analisi teorica per lo studio dell’azione diretta al
conseguimento del potere politico e al mutamento dei fini e delle strutture di questo.
In ambedue i casi, alla scienza politica si giustappongono altre scienze quali il diritto
(fondamentali al proposito il diritto costituzionale comparato e quello
internazionale), l’economia politica, la politica economica, la scienza delle finanze,
la sociologia e la storia. Anticamente non esisteva una scienza politica autonoma,
essendo la politica intimamente legata alla religione, alla morale e, più tardi, alla
filosofia. I primi testi apparsi sull’argomento furono raccolte di massime sull’arte di
a
a
governare (come le massime di faraoni egiziani della 7 e 8 dinastia, le massime di
Confucio e di Mencio, il trattato indiano di Kāmandaki); uno studia più specifico e
organico, per quanto non ancora svincolato dalla filosofia e dalla morale, si ebbe
nell’antica Grecia con Platone attraverso il disegno di una società ideale, e
soprattutto con Aristotele, che per primo elaborò una classificazione delle differenti
forme di governo. In epoca romana fu data prevalenza all’aspetto giuridico dei
rapporti politici senza pervenire tuttavia a una riflessione più approfondita
(Cicerone). Nuovamente legato alla religione con l’affermarsi del cristianesimo, il
pensiero politico nel medioevo fu essenzialmente sviluppato dalla Chiesa, che pose
l’accento sull’origine del potere e sulla sua legittimazione. I dottori della Chiesa, e
in particolare san Tommaso d’Aquino, sostennero che il potere proviene da Dio
attraverso la mediazione del popolo. Nel XIV sec. fu operata una separazione tra
potere spirituale e potere temporale che però rivendicarono entrambi un’origine
divina. Nel secolo successivo Machiavelli svincolò in maniera definitiva la politica