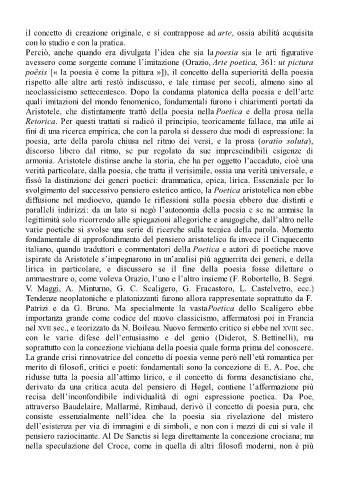Page 655 - Dizionario di Filosofia
P. 655
il concetto di creazione originale, e si contrappose ad arte, ossia abilità acquisita
con lo studio e con la pratica.
Perciò, anche quando era divulgata l’idea che sia la poesia sia le arti figurative
avessero come sorgente comune l’imitazione (Orazio, Arte poetica, 361: ut pictura
poësis [« la poesia è come la pittura »]), il concetto della superiorità della poesia
rispetto alle altre arti restò indiscusso, e tale rimase per secoli, almeno sino al
neoclassicismo settecentesco. Dopo la condanna platonica della poesia e dell’arte
quali imitazioni del mondo fenomenico, fondamentali furono i chiarimenti portati da
Aristotele, che distintamente trattò della poesia nella Poetica e della prosa nella
Retorica. Per questi trattati si radicò il principio, teoricamente fallace, ma utile ai
fini di una ricerca empirica, che con la parola si dessero due modi di espressione: la
poesia, arte della parola chiusa nel ritmo dei versi, e la prosa (oratio soluta),
discorso libero dal ritmo, se pur regolato da sue imprescindibili esigenze di
armonia. Aristotele distinse anche la storia, che ha per oggetto l’accaduto, cioè una
verità particolare, dalla poesia, che tratta il verisimile, ossia una verità universale, e
fissò la distinzione dei generi poetici: drammatica, epica, lirica. Essenziale per lo
svolgimento del successivo pensiero estetico antico, la Poetica aristotelica non ebbe
diffusione nel medioevo, quando le riflessioni sulla poesia ebbero due distinti e
paralleli indirizzi: da un lato si negò l’autonomia della poesia e se ne ammise la
legittimità solo ricorrendo alle spiegazioni allegoriche e anagogiche, dall’altro nelle
varie poetiche si svolse una serie di ricerche sulla tecnica della parola. Momento
fondamentale di approfondimento del pensiero aristotelico fu invece il Cinquecento
italiano, quando traduttori e commentatori della Poetica e autori di poetiche nuove
ispirate da Aristotele s’impegnarono in un’analisi più agguerrita dei generi, e della
lirica in particolare, e discussero se il fine della poesia fosse dilettare o
ammaestrare o, come voleva Orazio, l’uno e l’altro insieme (F. Robortello, B. Segni,
V. Maggi, A. Minturno, G. C. Scaligero, G. Fracastoro, L. Castelvetro, ecc.).
Tendenze neoplatoniche e platonizzanti furono allora rappresentate soprattutto da F.
Patrizi e da G. Bruno. Ma specialmente la vasta Poetica dello Scaligero ebbe
importanza grande come codice del nuovo classicismo, affermatosi poi in Francia
nel XVII sec., e teorizzato da N. Boileau. Nuovo fermento critico si ebbe nel XVIII sec.
con le varie difese dell’entusiasmo e del genio (Diderot, S. Bettinelli), ma
soprattutto con la concezione vichiana della poesia quale forma prima del conoscere.
La grande crisi rinnovatrice del concetto di poesia venne però nell’età romantica per
merito di filosofi, critici e poeti: fondamentali sono la concezione di E. A. Poe, che
ridusse tutta la poesia all’attimo lirico, e il concetto di forma desanctisiano che,
derivato da una critica acuta del pensiero di Hegel, contiene l’affermazione più
recisa dell’inconfondibile individualità di ogni espressione poetica. Da Poe,
attraverso Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud, derivò il concetto di poesia pura, che
consiste essenzialmente nell’idea che la poesia sia rivelazione del mistero
dell’esistenza per via di immagini e di simboli, e non con i mezzi di cui si vale il
pensiero raziocinante. Al De Sanctis si lega direttamente la concezione crociana; ma
nella speculazione del Croce, come in quella di altri filosofi moderni, non è più