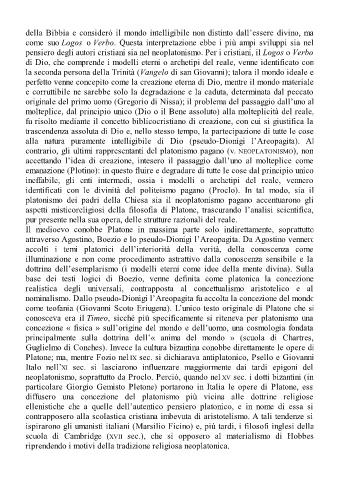Page 651 - Dizionario di Filosofia
P. 651
della Bibbia e considerò il mondo intelligibile non distinto dall’essere divino, ma
come suo Logos o Verbo. Questa interpretazione ebbe i più ampi sviluppi sia nel
pensiero degli autori cristiani sia nel neoplatonismo. Per i cristiani, il Logos o Verbo
di Dio, che comprende i modelli eterni o archetipi del reale, venne identificato con
la seconda persona della Trinità (Vangelo di san Giovanni); talora il mondo ideale e
perfetto venne concepito come la creazione eterna di Dio, mentre il mondo materiale
e corruttibile ne sarebbe solo la degradazione e la caduta, determinata dal peccato
originale del primo uomo (Gregorio di Nissa); il problema del passaggio dall’uno al
molteplice, dal principio unico (Dio o il Bene assoluto) alla molteplicità del reale,
fu risolto mediante il concetto biblicocristiano di creazione, con cui si giustifica la
trascendenza assoluta di Dio e, nello stesso tempo, la partecipazione di tutte le cose
alla natura puramente intelligibile di Dio (pseudo-Dionigi l’Areopagita). Al
contrario, gli ultimi rappresentanti del platonismo pagano (v. NEOPLATONISMO), non
accettando l’idea di creazione, intesero il passaggio dall’uno al molteplice come
emanazione (Plotino): in questo fluire e degradare di tutte le cose dal principio unico
ineffabile, gli enti intermedi, ossia i modelli o archetipi del reale, vennero
identificati con le divinità del politeismo pagano (Proclo). In tal modo, sia il
platonismo dei padri della Chiesa sia il neoplatonismo pagano accentuarono gli
aspetti misticoreligiosi della filosofia di Platone, trascurando l’analisi scientifica,
pur presente nella sua opera, delle strutture razionali del reale.
Il medioevo conobbe Platone in massima parte solo indirettamente, soprattutto
attraverso Agostino, Boezio e lo pseudo-Dionigi l’Areopagita. Da Agostino vennero
accolti i temi platonici dell’interiorità della verità, della conoscenza come
illuminazione e non come procedimento astrattivo dalla conoscenza sensibile e la
dottrina dell’esemplarismo (i modelli eterni come idee della mente divina). Sulla
base dei testi logici di Boezio, venne definita come platonica la concezione
realistica degli universali, contrapposta al concettualismo aristotelico e al
nominalismo. Dallo pseudo-Dionigi l’Areopagita fu accolta la concezione del mondo
come teofania (Giovanni Scoto Eriugena). L’unico testo originale di Platone che si
conosceva era il Timeo, sicché più specificamente si riteneva per platonismo una
concezione « fisica » sull’origine del mondo e dell’uomo, una cosmologia fondata
principalmente sulla dottrina dell’« anima del mondo » (scuola di Chartres,
Guglielmo di Conches). Invece la cultura bizantina conobbe direttamente le opere di
Platone; ma, mentre Fozio nel IX sec. si dichiarava antiplatonico, Psello e Giovanni
Italo nell’XI sec. si lasciarono influenzare maggiormente dai tardi epigoni del
neoplatonismo, soprattutto da Proclo. Perciò, quando nel XV sec. i dotti bizantini (in
particolare Giorgio Gemisto Pletone) portarono in Italia le opere di Platone, essi
diffusero una concezione del platonismo più vicina alle dottrine religiose
ellenistiche che a quelle dell’autentico pensiero platonico, e in nome di essa si
contrapposero alla scolastica cristiana imbevuta di aristotelismo. A tali tendenze si
ispirarono gli umanisti italiani (Marsilio Ficino) e, più tardi, i filosofi inglesi della
scuola di Cambridge (XVII sec.), che si opposero al materialismo di Hobbes
riprendendo i motivi della tradizione religiosa neoplatonica.