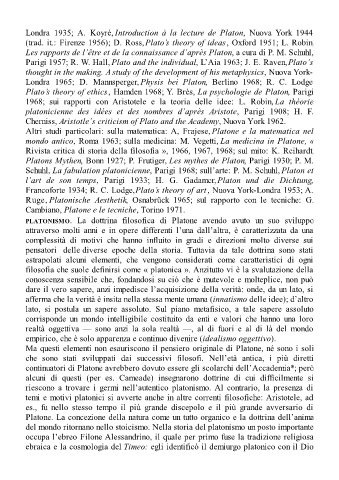Page 650 - Dizionario di Filosofia
P. 650
Londra 1935; A. Koyré, Introduction à la lecture de Platon, Nuova York 1944
(trad. it.: Firenze 1956); D. Ross, Plato’s theory of ideas, Oxford 1951; L. Robin,
Les rapports de l’être et de la connaissance d’après Platon, a cura di P. M. Schuhl,
Parigi 1957; R. W. Hall, Plato and the individual, L’Aia 1963; J. E. Raven, Plato’s
thought in the making. A study of the development of his metaphysics, Nuova York-
Londra 1965; D. Mannsperger, Physis bei Platon, Berlino 1968; R. C. Lodge,
Plato’s theory of ethics, Hamden 1968; Y. Brès, La psychologie de Platon, Parigi
1968; sui rapporti con Aristotele e la teoria delle idee: L. Robin, La théorie
platonicienne des idées et des nombres d’après Aristote, Parigi 1908; H. F.
Cherniss, Aristotle’s criticism of Plato and the Academy, Nuova York 1962.
Altri studi particolari: sulla matematica: A, Frajese, Platone e la matematica nel
mondo antico, Roma 1963; sulla medicina: M. Vegetti, La medicina in Platone, «
Rivista critica di storia della filosofia », 1966, 1967, 1968; sul mito: K. Reihardt,
Platons Mythen, Bonn 1927; P. Frutiger, Les mythes de Platon, Parigi 1930; P. M.
Schuhl, La fabulation platonicienne, Parigi 1968; sull’arte: P. M. Schuhl, Platon et
l’art de son temps, Parigi 1933; H. G. Gadamer, Platon und die Dichtung,
Francoforte 1934; R. C. Lodge, Plato’s theory of art, Nuova York-Londra 1953; A.
Ruge, Platonische Aesthetik, Osnabrück 1965; sul rapporto con le tecniche: G.
Cambiano, Platone e le tecniche, Torino 1971.
PLATONISMO. La dottrina filosofica di Platone avendo avuto un suo sviluppo
attraverso molti anni e in opere differenti l’una dall’altra, è caratterizzata da una
complessità di motivi che hanno influito in gradi e direzioni molto diverse sui
pensatori delle diverse epoche della storia. Tuttavia da tale dottrina sono stati
estrapolati alcuni elementi, che vengono considerati come caratteristici di ogni
filosofia che suole definirsi come « platonica ». Anzitutto vi è la svalutazione della
conoscenza sensibile che, fondandosi su ciò che è mutevole e molteplice, non può
dare il vero sapere, anzi impedisce l’acquisizione della verità: onde, da un lato, si
afferma che la verità è insita nella stessa mente umana (innatismo delle idee); d’altro
lato, si postula un sapere assoluto. Sul piano metafisico, a tale sapere assoluto
corrisponde un mondo intelligibile costituito da enti e valori che hanno una loro
realtà oggettiva — sono anzi la sola realtà —, al di fuori e al di là del mondo
empirico, che è solo apparenza e continuo divenire (idealismo oggettivo).
Ma questi elementi non esauriscono il pensiero originale di Platone, né sono i soli
che sono stati sviluppati dai successivi filosofi. Nell’età antica, i più diretti
continuatori di Platone avrebbero dovuto essere gli scolarchi dell’Accademia*; però
alcuni di questi (per es. Cameade) insegnarono dottrine di cui diffìcilmente si
riescono a trovare i germi nell’autentico platonismo. Al contrario, la presenza di
temi e motivi platonici si avverte anche in altre correnti filosofiche: Aristotele, ad
es., fu nello stesso tempo il più grande discepolo e il più grande avversario di
Platone. La concezione della natura come un tutto organico e la dottrina dell’anima
del mondo ritornano nello stoicismo. Nella storia del platonismo un posto importante
occupa l’ebreo Filone Alessandrino, il quale per primo fuse la tradizione religiosa
ebraica e la cosmologia del Timeo: egli identificò il demiurgo platonico con il Dio