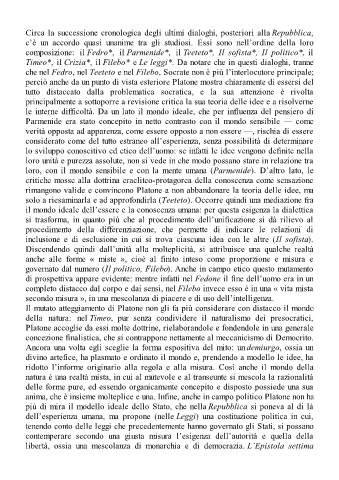Page 648 - Dizionario di Filosofia
P. 648
Circa la successione cronologica degli ultimi dialoghi, posteriori alla Repubblica,
c’è un accordo quasi unanime tra gli studiosi. Essi sono nell’ordine della loro
composizione: il Fedro*, il Parmenide*, il Teeteto*, Il sofista*, Il politico*, il
Timeo*, il Crizia*, il Filebo* e Le leggi*. Da notare che in questi dialoghi, tranne
che nel Fedro, nel Teeteto e nel Filebo, Socrate non è più l’interlocutore principale;
perciò anche da un punto di vista esteriore Platone mostra chiaramente di essersi del
tutto distaccato dalla problematica socratica, e la sua attenzione è rivolta
principalmente a sottoporre a revisione critica la sua teoria delle idee e a risolverne
le interne difficoltà. Da un lato il mondo ideale, che per influenza del pensiero di
Parmenide era stato concepito in netto contrasto con il mondo sensibile — come
verità opposta ad apparenza, come essere opposto a non essere —, rischia di essere
considerato come del tutto estraneo all’esperienza, senza possibilità di determinare
lo sviluppo conoscitivo ed etico dell’uomo: se infatti le idee vengono definite nella
loro unità e purezza assolute, non si vede in che modo possano stare in relazione tra
loro, con il mondo sensibile e con la mente umana (Parmenide). D’altro lato, le
critiche mosse alla dottrina eracliteo-protagorea della conoscenza come sensazione
rimangono valide e convincono Platone a non abbandonare la teoria delle idee, ma
solo a riesaminarla e ad approfondirla (Teeteto). Occorre quindi una mediazione fra
il mondo ideale dell’essere e la conoscenza umana: per questa esigenza la dialettica
si trasforma, in quanto più che al procedimento dell’unificazione si dà rilievo al
procedimento della differenziazione, che permette di indicare le relazioni di
inclusione e di esclusione in cui si trova ciascuna idea con le altre (Il sofista).
Discendendo quindi dall’unità alla molteplicità, si attribuisce una qualche realtà
anche alle forme « miste », cioè al finito inteso come proporzione e misura e
governato dal numero (Il politico, Filebo). Anche in campo etico questo mutamento
di prospettiva appare evidente: mentre infatti nel Fedone il fine dell’uomo era in un
completo distacco dal corpo e dai sensi, nel Filebo invece esso è in una « vita mista
secondo misura », in una mescolanza di piacere e di uso dell’intelligenza.
Il mutato atteggiamento di Platone non gli fa più considerare con distacco il mondo
della natura: nel Timeo, pur senza condividere il naturalismo dei presocratici,
Platone accoglie da essi molte dottrine, rielaborandole e fondendole in una generale
concezione finalistica, che si contrappone nettamente al meccanicismo di Democrito.
Ancora una volta egli sceglie la forma espositiva del mito: un demiurgo, ossia un
divino artefice, ha plasmato e ordinato il mondo e, prendendo a modello le idee, ha
ridotto l’informe originario alla regola e alla misura. Così anche il mondo della
natura è una realtà mista, in cui al mutevole e al transeunte si mescola la razionalità
delle forme pure, ed essendo organicamente concepito e disposto possiede una sua
anima, che è insieme molteplice e una. Infine, anche in campo politico Platone non ha
più di mira il modello ideale dello Stato, che nella Repubblica si poneva al di là
dell’esperienza umana, ma propone (nelle Leggi) una costituzione politica in cui,
tenendo conto delle leggi che precedentemente hanno governato gli Stati, si possano
contemperare secondo una giusta misura l’esigenza dell’autorità e quella della
libertà, ossia una mescolanza di monarchia e di democrazia. L’Epistola settima