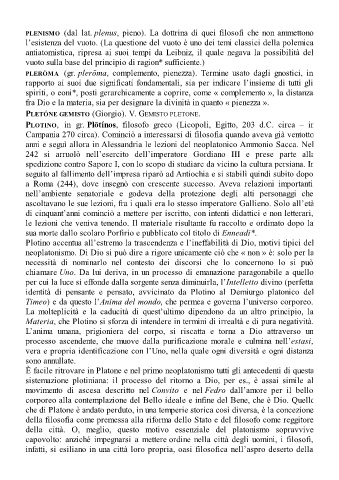Page 653 - Dizionario di Filosofia
P. 653
PLENISMO (dal lat. plenus, pieno). La dottrina di quei filosofi che non ammettono
l’esistenza del vuoto. (La questione del vuoto è uno dei temi classici della polemica
antiatomistica, ripresa ai suoi tempi da Leibniz, il quale negava la possibilità del
vuoto sulla base del principio di ragion* sufficiente.)
PLERÒMA (gr. plerōma, complemento, pienezza). Termine usato dagli gnostici, in
rapporto ai suoi due significati fondamentali, sia per indicare l’insieme di tutti gli
spiriti, o eoni*, posti gerarchicamente a coprire, come « complemento », la distanza
fra Dio e la materia, sia per designare la divinità in quanto « pienezza ».
PLETÓNE GEMISTO (Giorgio). V. GEMISTO PLETONE.
PLOTINO, in gr. Plōtínos, filosofo greco (Licopoli, Egitto, 203 d.C. circa – in
Campania 270 circa). Cominciò a interessarsi di filosofia quando aveva già ventotto
anni e seguì allora in Alessandria le lezioni del neoplatonico Ammonio Sacca. Nel
242 si arruolò nell’esercito dell’imperatore Gordiano III e prese parte alla
spedizione contro Sapore I, con lo scopo di studiare da vicino la cultura persiana. In
seguito al fallimento dell’impresa riparò ad Antiochia e si stabilì quindi subito dopo
a Roma (244), dove insegnò con crescente successo. Aveva relazioni importanti
nell’ambiente senatoriale e godeva della protezione degli alti personaggi che
ascoltavano le sue lezioni, fra i quali era lo stesso imperatore Gallieno. Solo all’età
di cinquant’anni cominciò a mettere per iscritto, con intenti didattici e non letterari,
le lezioni che veniva tenendo. Il materiale risultante fu raccolto e ordinato dopo la
sua morte dallo scolaro Porfirio e pubblicato col titolo di Enneadi*.
Plotino accentua all’estremo la trascendenza e l’ineffabilità di Dio, motivi tipici del
neoplatonismo. Di Dio si può dire a rigore unicamente ciò che « non » è: solo per la
necessità di nominarlo nel contesto dei discorsi che lo concernono lo si può
chiamare Uno. Da lui deriva, in un processo di emanazione paragonabile a quello
per cui la luce si effonde dalla sorgente senza diminuirla, l’Intelletto divino (perfetta
identità di pensante e pensato, avvicinato da Plotino al Demiurgo platonico del
Timeo) e da questo l’Anima del mondo, che permea e governa l’universo corporeo.
La molteplicità e la caducità di quest’ultimo dipendono da un altro principio, la
Materia, che Plotino si sforza di intendere in termini di irrealtà e di pura negatività.
L’anima umana, prigioniera del corpo, si riscatta e torna a Dio attraverso un
processo ascendente, che muove dalla purificazione morale e culmina nell’estasi,
vera e propria identificazione con l’Uno, nella quale ogni diversità e ogni distanza
sono annullate.
È facile ritrovare in Platone e nel primo neoplatonismo tutti gli antecedenti di questa
sistemazione plotiniana: il processo del ritorno a Dio, per es., è assai simile al
movimento di ascesa descritto nel Convito e nel Fedro dall’amore per il bello
corporeo alla contemplazione del Bello ideale e infine del Bene, che è Dio. Quello
che di Platone è andato perduto, in una temperie storica così diversa, è la concezione
della filosofia come premessa alla riforma dello Stato e del filosofo come reggitore
della città. O, meglio, questo motivo essenziale del platonismo sopravvive
capovolto: anziché impegnarsi a mettere ordine nella città degli uomini, i filosofi,
infatti, si esiliano in una città loro propria, oasi filosofica nell’aspro deserto della