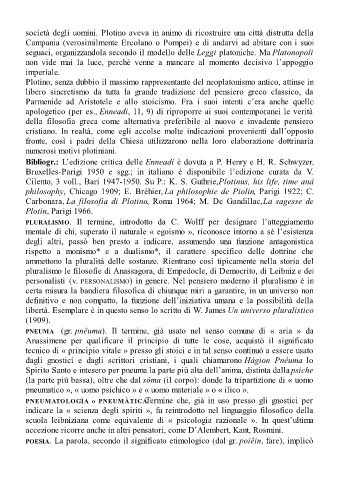Page 654 - Dizionario di Filosofia
P. 654
società degli uomini. Plotino aveva in animo di ricostruire una città distrutta della
Campania (verosimilmente Ercolano o Pompei) e di andarvi ad abitare con i suoi
seguaci, organizzandola secondo il modello delle Leggi platoniche. Ma Platonopoli
non vide mai la luce, perché venne a mancare al momento decisivo l’appoggio
imperiale.
Plotino, senza dubbio il massimo rappresentante del neoplatonismo antico, attinse in
libero sincretismo da tutta la grande tradizione del pensiero greco classico, da
Parmenide ad Aristotele e allo stoicismo. Fra i suoi intenti c’era anche quello
apologetico (per es., Enneadi, 11, 9) di riproporre ai suoi contemporanei le verità
della filosofia greca come alternativa preferibile al nuovo e invadente pensiero
cristiano. In realtà, come egli accolse molte indicazioni provenienti dall’opposto
fronte, così i padri della Chiesa utilizzarono nella loro elaborazione dottrinaria
numerosi motivi plotiniani.
Bibliogr.: L’edizione critica delle Enneadi è dovuta a P. Henry e H. R. Schwyzer,
Bruxelles-Parigi 1950 e sgg.; in italiano è disponibile l’edizione curata da V.
Cilento, 3 voll., Bari 1947-1950. Su P.: K. S. Guthrie, Plotinus, his life, time and
philosophy, Chicago 1909; E. Bréhier, La philosophie de Piolin, Parigi 1922; C.
Carbonara, La filosofia di Plotino, Roma 1964; M. De Gandillac, La sagesse de
Plotin, Parigi 1966.
PLURALISMO. Il termine, introdotto da C. Wolff per designare l’atteggiamento
mentale di chi, superato il naturale « egoismo », riconosce intorno a sé l’esistenza
degli altri, passò ben presto a indicare, assumendo una funzione antagonistica
rispetto a monismo* e a dualismo*, il carattere specifico delle dottrine che
ammettono la pluralità delle sostanze. Rientrano così tipicamente nella storia del
pluralismo le filosofie di Anassagora, di Empedocle, di Democrito, di Leibniz e dei
personalisti (v. PERSONALISMO) in genere. Nel pensiero moderno il pluralismo è in
certa misura la bandiera filosofica di chiunque miri a garantire, in un universo non
definitivo e non compatto, la funzione dell’iniziativa umana e la possibilità della
libertà. Esemplare è in questo senso lo scritto di W. James Un universo pluralistico
(1909).
PNEUMA (gr. pnêuma). Il termine, già usato nel senso comune di « aria » da
Anassimene per qualificare il principio di tutte le cose, acquistò il significato
tecnico di « principio vitale » presso gli stoici e in tal senso continuò a essere usato
dagli gnostici e dagli scrittori cristiani, i quali chiamarono Hágion Pnêuma lo
Spirito Santo e intesero per pneuma la parte più alta dell’anima, distinta dalla psiche
(la parte più bassa), oltre che dal sôma (il corpo): donde la tripartizione di « uomo
pneumatico », « uomo psichico » e « uomo materiale » o « ilico ».
PNEUMATOLOGÌA o PNEUMÀTICA. Termine che, già in uso presso gli gnostici per
indicare la « scienza degli spiriti », fu reintrodotto nel linguaggio filosofico della
scuola leibniziana come equivalente di « psicologia razionale ». In quest’ultima
accezione ricorre anche in altri pensatori, come D’Alembert, Kant, Rosmini.
POESIA. La parola, secondo il significato etimologico (dal gr. poiêin, fare), implicò