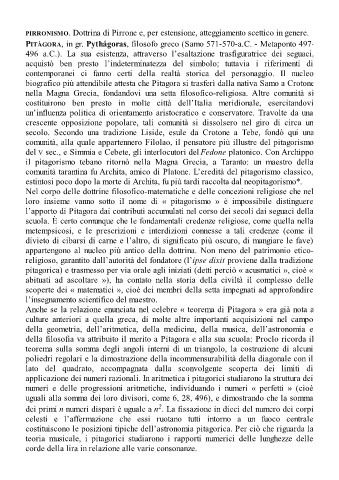Page 643 - Dizionario di Filosofia
P. 643
PIRRONISMO. Dottrina di Pirrone e, per estensione, atteggiamento scettico in genere.
PITÀGORA, in gr. Pythágoras, filosofo greco (Samo 571-570-a.C. - Metaponto 497-
496 a.C.). La sua esistenza, attraverso l’esaltazione trasfiguratrice dei seguaci,
acquistò ben presto l’indeterminatezza del simbolo; tuttavia i riferimenti di
contemporanei ci fanno certi della realtà storica del personaggio. Il nucleo
biografico più attendibile attesta che Pitagora si trasferì dalla nativa Samo a Crotone
nella Magna Grecia, fondandovi una setta filosofico-religiosa. Altre comunità si
costituirono ben presto in molte città dell’Italia meridionale, esercitandovi
un’influenza politica di orientamento aristocratico e conservatore. Travolte da una
crescente opposizione popolare, tali comunità si dissolsero nel giro di circa un
secolo. Secondo una tradizione Liside, esule da Crotone a Tebe, fondò qui una
comunità, alla quale appartennero Filolao, il pensatore più illustre del pitagorismo
del V sec., e Simmia e Cebete, gli interlocutori del Fedone platonico. Con Archippo
il pitagorismo tebano ritornò nella Magna Grecia, a Taranto: un maestro della
comunità tarantina fu Archita, amico di Platone. L’eredità del pitagorismo classico,
estintosi poco dopo la morte di Archita, fu più tardi raccolta dal neopitagorismo*.
Nel corpo delle dottrine filosofico-matematiche e delle concezioni religiose che nel
loro insieme vanno sotto il nome di « pitagorismo » è impossibile distinguere
l’apporto di Pitagora dai contributi accumulati nel corso dei secoli dai seguaci della
scuola. È certo comunque che le fondamentali credenze religiose, come quella nella
metempsicosi, e le prescrizioni e interdizioni connesse a tali credenze (come il
divieto di cibarsi di carne e l’altro, di significato più oscuro, di mangiare le fave)
appartengono al nucleo più antico della dottrina. Non meno del patrimonio etico-
religioso, garantito dall’autorità del fondatore (l’ipse dixit proviene dalla tradizione
pitagorica) e trasmesso per via orale agli iniziati (detti perciò « acusmatici », cioè «
abituati ad ascoltare »), ha contato nella storia della civiltà il complesso delle
scoperte dei « matematici », cioè dei membri della setta impegnati ad approfondire
l’insegnamento scientifico del maestro.
Anche se la relazione enunciata nel celebre « teorema di Pitagora » era già nota a
culture anteriori a quella greca, di molte altre importanti acquisizioni nel campo
della geometria, dell’aritmetica, della medicina, della musica, dell’astronomia e
della filosofia va attribuito il merito a Pitagora e alla sua scuola: Proclo ricorda il
teorema sulla somma degli angoli interni di un triangolo, la costruzione di alcuni
poliedri regolari e la dimostrazione della incommensurabilità della diagonale con il
lato del quadrato, accompagnata dalla sconvolgente scoperta dei limiti di
applicazione dei numeri razionali. In aritmetica i pitagorici studiarono la struttura dei
numeri e delle progressioni aritmetiche, individuando i numeri « perfetti » (cioè
uguali alla somma dei loro divisori, come 6, 28, 496), e dimostrando che la somma
2
dei primi n numeri dispari è uguale a n . La fissazione in dieci del numero dei corpi
celesti e l’affermazione che essi ruotano tutti intorno a un fuoco centrale
costituiscono le posizioni tipiche dell’astronomia pitagorica. Per ciò che riguarda la
teoria musicale, i pitagorici studiarono i rapporti numerici delle lunghezze delle
corde della lira in relazione alle varie consonanze.