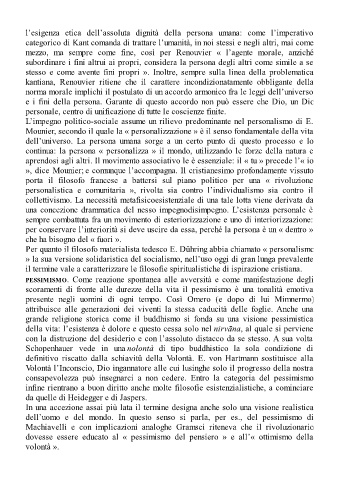Page 638 - Dizionario di Filosofia
P. 638
l’esigenza etica dell’assoluta dignità della persona umana: come l’imperativo
categorico di Kant comanda di trattare l’umanità, in noi stessi e negli altri, mai come
mezzo, ma sempre come fine, così per Renouvier « l’agente morale, anziché
subordinare i fini altrui ai propri, considera la persona degli altri come simile a se
stesso e come avente fini propri ». Inoltre, sempre sulla linea della problematica
kantiana, Renouvier ritiene che il carattere incondizionatamente obbligante della
norma morale implichi il postulato di un accordo armonico fra le leggi dell’universo
e i fini della persona. Garante di questo accordo non può essere che Dio, un Dio
personale, centro di unificazione di tutte le coscienze finite.
L’impegno politico-sociale assume un rilievo predominante nel personalismo di E.
Mounier, secondo il quale la « personalizzazione » è il senso fondamentale della vita
dell’universo. La persona umana sorge a un certo punto di questo processo e lo
continua: la persona « personalizza » il mondo, utilizzando le forze della natura e
aprendosi agli altri. Il movimento associativo le è essenziale: il « tu » precede l’« io
», dice Mounier; e comunque l’accompagna. Il cristianesimo profondamente vissuto
porta il filosofo francese a battersi sul piano politico per una « rivoluzione
personalistica e comunitaria », rivolta sia contro l’individualismo sia contro il
collettivismo. La necessità metafisicoesistenziale di una tale lotta viene derivata da
una concezione drammatica del nesso impegnodisimpegno. L’esistenza personale è
sempre combattuta fra un movimento di esteriorizzazione e uno di interiorizzazione:
per conservare l’interiorità si deve uscire da essa, perché la persona è un « dentro »
che ha bisogno del « fuori ».
Per quanto il filosofo materialista tedesco E. Dühring abbia chiamato « personalismo
» la sua versione solidaristica del socialismo, nell’uso oggi di gran lunga prevalente
il termine vale a caratterizzare le filosofie spiritualistiche di ispirazione cristiana.
PESSIMISMO. Come reazione spontanea alle avversità e come manifestazione degli
scoramenti di fronte alle durezze della vita il pessimismo è una tonalità emotiva
presente negli uomini di ogni tempo. Così Omero (e dopo di lui Mimnermo)
attribuisce alle generazioni dei viventi la stessa caducità delle foglie. Anche una
grande religione storica come il buddhismo si fonda su una visione pessimistica
della vita: l’esistenza è dolore e questo cessa solo nel nirvāna, al quale si perviene
con la distruzione del desiderio e con l’assoluto distacco da se stesso. A sua volta
Schopenhauer vede in una nolontà di tipo buddhistico la sola condizione di
definitivo riscatto dalla schiavitû della Volontà. E. von Hartmann sostituisce alla
Volontà l’Inconscio, Dio ingannatore alle cui lusinghe solo il progresso della nostra
consapevolezza può insegnarci a non cedere. Entro la categoria del pessimismo
infine rientrano a buon diritto anche molte filosofie esistenzialistiche, a cominciare
da quelle di Heidegger e di Jaspers.
In una accezione assai più lata il termine designa anche solo una visione realistica
dell’uomo e del mondo. In questo senso si parla, per es., del pessimismo di
Machiavelli e con implicazioni analoghe Gramsci riteneva che il rivoluzionario
dovesse essere educato al « pessimismo del pensiero » e all’« ottimismo della
volontà ».