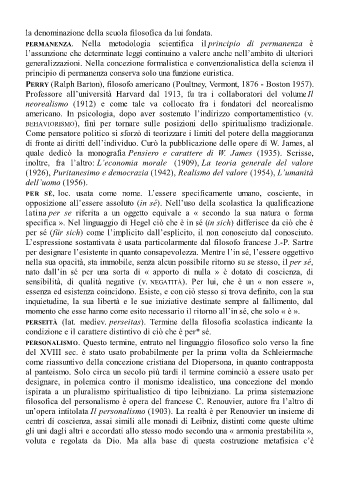Page 637 - Dizionario di Filosofia
P. 637
la denominazione della scuola filosofica da lui fondata.
PERMANENZA. Nella metodologia scientifica il principio di permanenza è
l’assunzione che determinate leggi continuino a valere anche nell’ambito di ulteriori
generalizzazioni. Nella concezione formalistica e convenzionalistica della scienza il
principio di permanenza conserva solo una funzione euristica.
PERRY (Ralph Barton), filosofo americano (Poultney, Vermont, 1876 - Boston 1957).
Professore all’università Harvard dal 1913, fu tra i collaboratori del volume Il
neorealismo (1912) e come tale va collocato fra i fondatori del neorealismo
americano. In psicologia, dopo aver sostenuto l’indirizzo comportamentistico (v.
BEHAVIORISMO), finì per tornare sulle posizioni dello spiritualismo tradizionale.
Come pensatore politico si sforzò di teorizzare i limiti del potere della maggioranza
di fronte ai diritti dell’individuo. Curò la pubblicazione delle opere di W. James, al
quale dedicò la monografia Pensiero e carattere di W. James (1935). Scrisse,
inoltre, fra l’altro: L’economia morale (1909), La teoria generale del valore
(1926), Puritanesimo e democrazia (1942), Realismo del valore (1954), L’umanità
dell’uomo (1956).
PER SÉ, loc. usata come nome. L’essere specificamente umano, cosciente, in
opposizione all’essere assoluto (in sé). Nell’uso della scolastica la qualificazione
latina per se riferita a un oggetto equivale a « secondo la sua natura o forma
specifica ». Nel linguaggio di Hegel ciò che è in sé (in sich) differisce da ciò che è
per sé (für sich) come l’implicito dall’esplicito, il non conosciuto dal conosciuto.
L’espressione sostantivata è usata particolarmente dal filosofo francese J.-P. Sartre
per designare l’esistente in quanto consapevolezza. Mentre l’in sé, l’essere oggettivo
nella sua opacità, sta immobile, senza alcun possibile ritorno su se stesso, il per sé,
nato dall’in sé per una sorta di « apporto di nulla » è dotato di coscienza, di
sensibilità, di qualità negative (v. NEGATITÀ). Per lui, che è un « non essere »,
essenza ed esistenza coincidono. Esiste, e con ciò stesso si trova definito, con la sua
inquietudine, la sua libertà e le sue iniziative destinate sempre al fallimento, dal
momento che esse hanno come esito necessario il ritorno all’in sé, che solo « è ».
PERSEITÀ (lat. mediev. perseitas). Termine della filosofia scolastica indicante la
condizione e il carattere distintivo di ciò che è per* sé.
PERSONALISMO. Questo termine, entrato nel linguaggio filosofico solo verso la fine
del XVIII sec. è stato usato probabilmente per la prima volta da Schleiermacher
come riassuntivo della concezione cristiana del Diopersona, in quanto contrapposta
al panteismo. Solo circa un secolo più tardi il termine cominciò a essere usato per
designare, in polemica contro il monismo idealistico, una concezione del mondo
ispirata a un pluralismo spiritualistico di tipo leibniziano. La prima sistemazione
filosofica del personalismo è opera del francese C. Renouvier, autore fra l’altro di
un’opera intitolata Il personalismo (1903). La realtà è per Renouvier un insieme di
centri di coscienza, assai simili alle monadi di Leibniz, distinti come queste ultime
gli uni dagli altri e accordati allo stesso modo secondo una « armonia prestabilita »,
voluta e regolata da Dio. Ma alla base di questa costruzione metafisica c’è