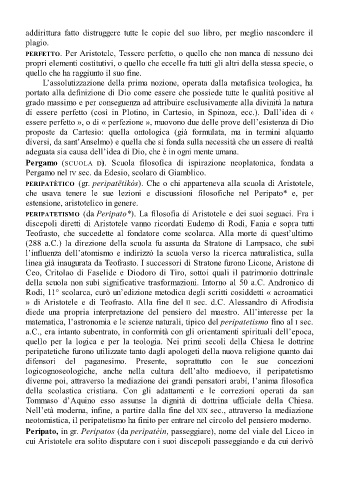Page 636 - Dizionario di Filosofia
P. 636
addirittura fatto distruggere tutte le copie del suo libro, per meglio nascondere il
plagio.
PERFETTO. Per Aristotele, Tessere perfetto, o quello che non manca di nessuno dei
propri elementi costitutivi, o quello che eccelle fra tutti gli altri della stessa specie, o
quello che ha raggiunto il suo fine.
L’assolutizzazione della prima nozione, operata dalla metafisica teologica, ha
portato alla definizione di Dio come essere che possiede tutte le qualità positive al
grado massimo e per conseguenza ad attribuire esclusivamente alla divinità la natura
di essere perfetto (così in Plotino, in Cartesio, in Spinoza, ecc.). Dall’idea di «
essere perfetto », o di « perfezione », muovono due delle prove dell’esistenza di Dio
proposte da Cartesio: quella ontologica (già formulata, ma in termini alquanto
diversi, da sant’Anselmo) e quella che si fonda sulla necessità che un essere di realtà
adeguata sia causa dell’idea di Dio, che è in ogni mente umana.
Pergamo (SCUOLA DI). Scuola filosofica di ispirazione neoplatonica, fondata a
Pergamo nel IV sec. da Edesio, scolaro di Giamblico.
PERIPATÈTICO (gr. peripatētikós). Che o chi apparteneva alla scuola di Aristotele,
che usava tenere le sue lezioni e discussioni filosofiche nel Peripato* e, per
estensione, aristotelico in genere.
PERIPATETISMO (da Peripato*). La filosofia di Aristotele e dei suoi seguaci. Fra i
discepoli diretti di Aristotele vanno ricordati Eudemo di Rodi, Fania e sopra tutti
Teofrasto, che succedette al fondatore come scolarca. Alla morte di quest’ultimo
(288 a.C.) la direzione della scuola fu assunta da Stratone di Lampsaco, che subì
l’influenza dell’atomismo e indirizzò la scuola verso la ricerca naturalistica, sulla
linea già inaugurata da Teofrasto. I successori di Stratone furono Licone, Aristone di
Ceo, Critolao di Faselide e Diodoro di Tiro, sotto i quali il patrimonio dottrinale
della scuola non subì significative trasformazioni. Intorno al 50 a.C. Andronico di
Rodi, 11° scolarca, curò un’edizione metodica degli scritti cosiddetti « acroamatici
» di Aristotele e di Teofrasto. Alla fine del II sec. d.C. Alessandro di Afrodisia
diede una propria interpretazione del pensiero del maestro. All’interesse per la
matematica, l’astronomia e le scienze naturali, tipico del peripatetismo fino al I sec.
a.C., era intanto subentrato, in conformità con gli orientamenti spirituali dell’epoca,
quello per la logica e per la teologia. Nei primi secoli della Chiesa le dottrine
peripatetiche furono utilizzate tanto dagli apologeti della nuova religione quanto dai
difensori del paganesimo. Presente, soprattutto con le sue concezioni
logicognoseologiche, anche nella cultura dell’alto medioevo, il peripatetismo
divenne poi, attraverso la mediazione dei grandi pensatori arabi, l’anima filosofica
della scolastica cristiana. Con gli adattamenti e le correzioni operati da san
Tommaso d’Aquino esso assunse la dignità di dottrina ufficiale della Chiesa.
Nell’età moderna, infine, a partire dalla fine del XIX sec., attraverso la mediazione
neotomistica, il peripatetismo ha finito per entrare nel circolo del pensiero moderno.
Peripato, in gr. Peripatos (da peripatèin, passeggiare), nome del viale del Liceo in
cui Aristotele era solito disputare con i suoi discepoli passeggiando e da cui derivò