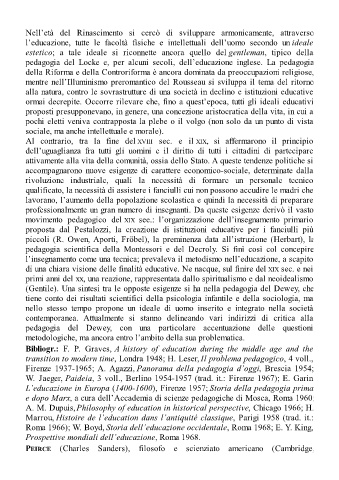Page 632 - Dizionario di Filosofia
P. 632
Nell’età del Rinascimento si cercò di sviluppare armonicamente, attraverso
l’educazione, tutte le facoltà fìsiche e intellettuali dell’uomo secondo un ideale
estetico; a tale ideale si riconnette ancora quello del gentleman, tipico della
pedagogia del Locke e, per alcuni secoli, dell’educazione inglese. La pedagogia
della Riforma e della Controriforma è ancora dominata da preoccupazioni religiose,
mentre nell’Illuminismo preromantico del Rousseau si sviluppa il tema del ritorno
alla natura, contro le sovrastrutture di una società in declino e istituzioni educative
ormai decrepite. Occorre rilevare che, fino a quest’epoca, tutti gli ideali educativi
proposti presupponevano, in genere, una concezione aristocratica della vita, in cui a
pochi eletti veniva contrapposta la plebe o il volgo (non solo da un punto di vista
sociale, ma anche intellettuale e morale).
Al contrario, tra la fine del XVIII sec. e il XIX, si affermarono il principio
dell’uguaglianza fra tutti gli uomini e il diritto di tutti i cittadini di partecipare
attivamente alla vita della comunità, ossia dello Stato. A queste tendenze politiche si
accompagnarono nuove esigenze di carattere economico-sociale, determinate dalla
rivoluzione industriale, quali la necessità di formare un personale tecnico
qualificato, la necessità di assistere i fanciulli cui non possono accudire le madri che
lavorano, l’aumento della popolazione scolastica e quindi la necessità di preparare
professionalmente un gran numero di insegnanti. Da queste esigenze derivò il vasto
movimento pedagogico del XIX see.: l’organizzazione dell’insegnamento primario
proposta dal Pestalozzi, la creazione di istituzioni educative per i fanciulli più
piccoli (R. Owen, Aporti, Fröbel), la preminenza data all’istruzione (Herbart), la
pedagogia scientifica della Montessori e del Decroly. Si finì così col concepire
l’insegnamento come una tecnica; prevaleva il metodismo nell’educazione, a scapito
di una chiara visione delle finalità educative. Ne nacque, sul finire del XIX sec. e nei
primi anni del xx, una reazione, rappresentata dallo spiritualismo e dal neoidealismo
(Gentile). Una sintesi tra le opposte esigenze si ha nella pedagogia del Dewey, che
tiene conto dei risultati scientifici della psicologia infantile e della sociologia, ma
nello stesso tempo propone un ideale di uomo inserito e integrato nella società
contemporanea. Attualmente si stanno delineando vari indirizzi di critica alla
pedagogia del Dewey, con una particolare accentuazione delle questioni
metodologiche, ma ancora entro l’ambito della sua problematica.
Bibliogr.: F. P. Graves, A history of education during the middle age and the
transition to modern time, Londra 1948; H. Leser, Il problema pedagogico, 4 voll.,
Firenze 1937-1965; A. Agazzi, Panorama della pedagogia d’oggi, Brescia 1954;
W. Jaeger, Paideia, 3 voll., Berlino 1954-1957 (trad. it.: Firenze 1967); E. Garin,
L’educazione in Europa (1400-1600), Firenze 1957; Storia della pedagogia prima
e dopo Marx, a cura dell’Accademia di scienze pedagogiche di Mosca, Roma 1960;
A. M. Dupuis, Philosophy of education in historical perspective, Chicago 1966; H.
Marrou, Histoire de l’education dans l’antiquité classique, Parigi 1958 (trad. it.:
Roma 1966); W. Boyd, Storia dell’educazione occidentale, Roma 1968; E. Y. King,
Prospettive mondiali dell’educazione, Roma 1968.
PEIRCE (Charles Sanders), filosofo e scienziato americano (Cambridge,