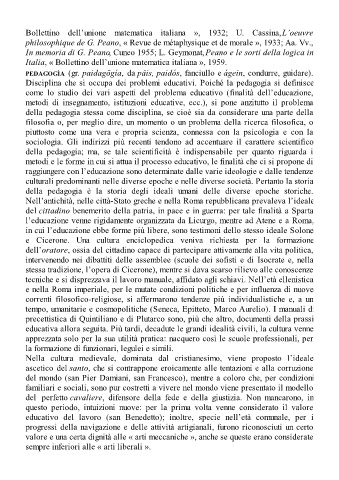Page 631 - Dizionario di Filosofia
P. 631
Bollettino dell’unione matematica italiana », 1932; U. Cassina, L’oeuvre
philosophique de G. Peano, « Revue de métaphysique et de morale », 1933; Aa. Vv.,
In memoria di G. Peano, Cuneo 1955; L. Geymonat, Peano e le sorti della logica in
Italia, « Bollettino dell’unione matematica italiana », 1959.
PEDAGOGÌA (gr. paidagōgía, da pâis, paidós, fanciullo e ágein, condurre, guidare).
Disciplina che si occupa dei problemi educativi. Poiché la pedagogia si definisce
come lo studio dei vari aspetti del problema educativo (finalità dell’educazione,
metodi di insegnamento, istituzioni educative, ecc.), si pone anzitutto il problema
della pedagogia stessa come disciplina, se cioè sia da considerare una parte della
filosofia o, per meglio dire, un momento o un problema della ricerca filosofica, o
piuttosto come una vera e propria scienza, connessa con la psicologia e con la
sociologia. Gli indirizzi più recenti tendono ad accentuare il carattere scientifico
della pedagogia; ma, se tale scientificità è indispensabile per quanto riguarda i
metodi e le forme in cui si attua il processo educativo, le finalità che ci si propone di
raggiungere con l’educazione sono determinate dalle varie ideologie e dalle tendenze
culturali predominanti nelle diverse epoche e nelle diverse società. Pertanto la storia
della pedagogia è la storia degli ideali umani delle diverse epoche storiche.
Nell’antichità, nelle città-Stato greche e nella Roma repubblicana prevaleva l’ideale
del cittadino benemerito della patria, in pace e in guerra: per tale finalità a Sparta
l’educazione venne rigidamente organizzata da Licurgo, mentre ad Atene e a Roma,
in cui l’educazione ebbe forme più libere, sono testimoni dello stesso ideale Solone
e Cicerone. Una cultura enciclopedica veniva richiesta per la formazione
dell’oratore, ossia del cittadino capace di partecipare attivamente alla vita politica,
intervenendo nei dibattiti delle assemblee (scuole dei sofisti e di Isocrate e, nella
stessa tradizione, l’opera di Cicerone), mentre si dava scarso rilievo alle conoscenze
tecniche e si disprezzava il lavoro manuale, affidato agli schiavi. Nell’età ellenistica
e nella Roma imperiale, per le mutate condizioni politiche e per influenza di nuove
correnti filosofico-religiose, si affermarono tendenze più individualistiche e, a un
tempo, umanitarie e cosmopolitiche (Seneca, Epitteto, Marco Aurelio). I manuali di
precettistica di Quintiliano e di Plutarco sono, più che altro, documenti della prassi
educativa allora seguita. Più tardi, decadute le grandi idealità civili, la cultura venne
apprezzata solo per la sua utilità pratica: nacquero così le scuole professionali, per
la formazione di funzionari, legulei e simili.
Nella cultura medievale, dominata dal cristianesimo, viene proposto l’ideale
ascetico del santo, che si contrappone eroicamente alle tentazioni e alla corruzione
del mondo (san Pier Damiani, san Francesco), mentre a coloro che, per condizioni
familiari e sociali, sono pur costretti a vivere nel mondo viene presentato il modello
del perfetto cavaliere, difensore della fede e della giustizia. Non mancarono, in
questo periodo, intuizioni nuove: per la prima volta venne considerato il valore
educativo del lavoro (san Benedetto); inoltre, specie nell’età comunale, per i
progressi della navigazione e delle attività artigianali, furono riconosciuti un certo
valore e una certa dignità alle « arti meccaniche », anche se queste erano considerate
sempre inferiori alle « arti liberali ».