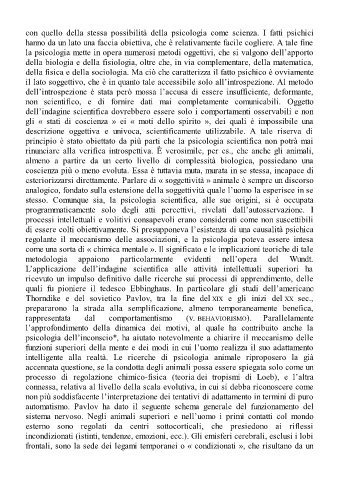Page 634 - Dizionario di Filosofia
P. 634
con quello della stessa possibilità della psicologia come scienza. I fatti psichici
hanno da un lato una faccia obiettiva, che è relativamente facile cogliere. A tale fine
la psicologia mette in opera numerosi metodi oggettivi, che si valgono dell’apporto
della biologia e della fisiologia, oltre che, in via complementare, della matematica,
della fìsica e della sociologia. Ma ciò che caratterizza il fatto psichico è ovviamente
il lato soggettivo, che è in quanto tale accessibile solo all’introspezione. Al metodo
dell’introspezione è stata però mossa l’accusa di essere insufficiente, deformante,
non scientifico, e di fornire dati mai completamente comunicabili. Oggetto
dell’indagine scientifica dovrebbero essere solo i comportamenti osservabili e non
gli « stati di coscienza » ei « moti dello spirito », dei quali è impossibile una
descrizione oggettiva e univoca, scientificamente utilizzabile. A tale riserva di
principio è stato obiettato da più parti che la psicologia scientifica non potrà mai
rinunciare alla verifica introspettiva. È verosimile, per es., che anche gli animali,
almeno a partire da un certo livello di complessità biologica, possiedano una
coscienza più o meno evoluta. Essa è tuttavia muta, murata in se stessa, incapace di
esteriorizzarsi direttamente. Parlare di « soggettività » animale è sempre un discorso
analogico, fondato sulla estensione della soggettività quale l’uomo la esperisce in se
stesso. Comunque sia, la psicologia scientifica, alle sue origini, si è occupata
programmaticamente solo degli atti percettivi, rivelati dall’autosservazione. I
processi intellettuali e volitivi consapevoli erano considerati come non suscettibili
di essere colti obiettivamente. Si presupponeva l’esistenza di una causalità psichica
regolante il meccanismo delle associazioni, e la psicologia poteva essere intesa
come una sorta di « chimica mentale ». Il significato e le implicazioni teoriche di tale
metodologia appaiono particolarmente evidenti nell’opera del Wundt.
L’applicazione dell’indagine scientifica alle attività intellettuali superiori ha
ricevuto un impulso definitivo dalle ricerche sui processi di apprendimento, delle
quali fu pioniere il tedesco Ebbinghaus. In particolare gli studi dell’americano
Thorndike e del sovietico Pavlov, tra la fine del XIX e gli inizi del XX sec.,
prepararono la strada alla semplificazione, almeno temporaneamente benefica,
rappresentata dal comportamentismo (v. BEHAVIORISMO). Parallelamente
l’approfondimento della dinamica dei motivi, al quale ha contribuito anche la
psicologia dell’inconscio*, ha aiutato notevolmente a chiarire il meccanismo delle
funzioni superiori della mente e dei modi in cui l’uomo realizza il suo adattamento
intelligente alla realtà. Le ricerche di psicologia animale riproposero la già
accennata questione, se la condotta degli animali possa essere spiegata solo come un
processo di regolazione chimico-fisica (teoria dei tropismi di Loeb), e l’altra
connessa, relativa al livello della scala evolutiva, in cui si debba riconoscere come
non più soddisfacente l’interpretazione dei tentativi di adattamento in termini di puro
automatismo. Pavlov ha dato il seguente schema generale del funzionamento del
sistema nervoso. Negli animali superiori e nell’uomo i primi contatti col mondo
esterno sono regolati da centri sottocorticali, che presiedono ai riflessi
incondizionati (istinti, tendenze, emozioni, ecc.). Gli emisferi cerebrali, esclusi i lobi
frontali, sono la sede dei legami temporanei o « condizionati », che risultano da un