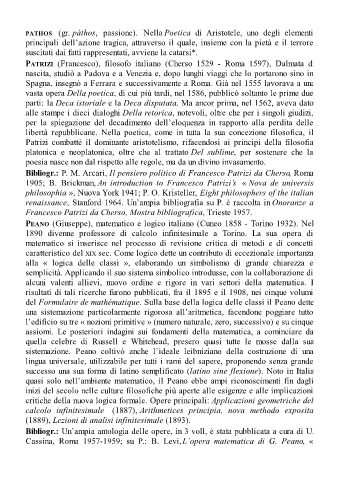Page 630 - Dizionario di Filosofia
P. 630
PATHOS (gr. páthos, passione). Nella Poetica di Aristotele, uno degli elementi
principali dell’azione tragica, attraverso il quale, insieme con la pietà e il terrore
suscitati dai fatti rappresentati, avviene la catarsi*.
PATRIZI (Francesco), filosofo italiano (Cherso 1529 - Roma 1597), Dalmata di
nascita, studiò a Padova e a Venezia e, dopo lunghi viaggi che lo portarono sino in
Spagna, insegnò a Ferrara e successivamente a Roma. Già nel 1555 lavorava a una
vasta opera Della poetica, di cui più tardi, nel 1586, pubblicò soltanto le prime due
parti: la Deca istoriale e la Deca disputata. Ma ancor prima, nel 1562, aveva dato
alle stampe i dieci dialoghi Della retorica, notevoli, oltre che per i singoli giudizi,
per la spiegazione del decadimento dell’eloquenza in rapporto alla perdita delle
libertà repubblicane. Nella poetica, come in tutta la sua concezione filosofica, il
Patrizi combattè il dominante aristotelismo, rifacendosi ai principi della filosofia
platonica e neoplatonica, oltre che al trattato Del sublime, per sostenere che la
poesia nasce non dal rispetto alle regole, ma da un divino invasamento.
Bibliogr.: P. M. Arcari, Il pensiero politico di Francesco Patrizi da Cherso, Roma
1905; B. Brickman, An introduction to Francesco Patrizi’s « Nova de universis
philosophia », Nuova York 1941; P. O. Kristeller, Eight philosophers of the italian
renaissance, Stanford 1964. Un’ampia bibliografia su P. è raccolta in Onoranze a
Francesco Patrizi da Cherso, Mostra bibliografica, Trieste 1957.
PEANO (Giuseppe), matematico e logico italiano (Cuneo 1858 - Torino 1932). Nel
1890 divenne professore di calcolo infinitesimale a Torino. La sua opera di
matematico si inserisce nel processo di revisione critica di metodi e di concetti
caratteristico del XIX sec. Come logico dette un contributo di eccezionale importanza
alla « logica delle classi », elaborando un simbolismo di grande chiarezza e
semplicità. Applicando il suo sistema simbolico introdusse, con la collaborazione di
alcuni valenti allievi, nuovo ordine e rigore in vari settori della matematica. I
risultati di tali ricerche furono pubblicati, fra il 1895 e il 1908, nei cinque volumi
del Formulaire de mathématique. Sulla base della logica delle classi il Peano dette
una sistemazione particolarmente rigorosa all’aritmetica, facendone poggiare tutto
l’edificio su tre « nozioni primitive » (numero naturale, zero, successivo) e su cinque
assiomi. Le posteriori indagini sui fondamenti della matematica, a cominciare da
quella celebre di Russell e Whitehead, presero quasi tutte le mosse dalla sua
sistemazione. Peano coltivò anche l’ideale leibniziano della costruzione di una
lingua universale, utilizzabile per tutti i rami del sapere, proponendo senza grande
successo una sua forma di latino semplificato (latino sine flexione). Noto in Italia
quasi solo nell’ambiente matematico, il Peano ebbe ampi riconoscimenti fin dagli
inizi del secolo nelle culture filosofiche più aperte alle esigenze e alle implicazioni
critiche della nuova logica formale. Opere principali: Applicazioni geometriche del
calcolo infinitesimale (1887), Arithmetices principia, nova methodo exposita
(1889), Lezioni di analisi infinitesimale (1893).
Bibliogr.: Un’ampia antologia delle opere, in 3 voll, è stata pubblicata a cura di U.
Cassina, Roma 1957-1959; su P.: B. Levi, L’opera matematica di G. Peano, «