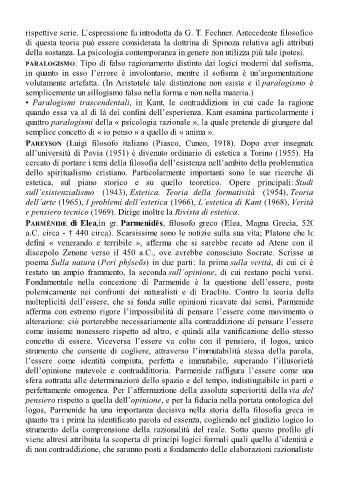Page 625 - Dizionario di Filosofia
P. 625
rispettive serie. L’espressione fu introdotta da G. T. Fechner. Antecedente filosofico
di questa teoria può essere considerata la dottrina di Spinoza relativa agli attributi
della sostanza. La psicologia contemporanea in genere non utilizza più tale ipotesi.
PARALOGISMO. Tipo di falso ragionamento distinto dai logici moderni dal sofisma,
in quanto in esso l’errore è involontario, mentre il sofisma è un’argomentazione
volutamente artefatta. (In Aristotele tale distinzione non esiste e il paralogismo è
semplicemente un sillogismo falso nella forma e non nella materia.)
• Paralogismi trascendentali, in Kant, le contraddizioni in cui cade la ragione
quando essa va al di là dei confini dell’esperienza. Kant esamina particolarmente i
quattro paralogismi della « psicologia razionale », la quale pretende di giungere dal
semplice concetto di « io penso » a quello di « anima ».
PAREYSON (Luigi filosofo italiano (Piasco, Cuneo, 1918). Dopo aver insegnato
all’università di Pavia (1951) è divenuto ordinario di estetica a Torino (1955). Ha
cercato di portare i temi della filosofia dell’esistenza nell’ambito della problematica
dello spiritualismo cristiano. Particolarmente importanti sono le sue ricerche di
estetica, sul piano storico e su quello teoretico. Opere principali: Studi
sull’esistenzialismo (1943), Estetica. Teoria della formatività (1954), Teoria
dell’arte (1965), I problemi dell’estetica (1966), L’estetica di Kant (1968), Verità
e pensiero tecnico (1969). Dirige inoltre la Rivista di estetica.
PARMÈNIDE di Elea,in gr. Parmenídēs, filosofo greco (Elea, Magna Grecia, 520
a.C. circa - † 440 circa). Scarsissime sono le notizie sulla sua vita; Platone che lo
definì « venerando e terribile », afferma che si sarebbe recato ad Atene con il
discepolo Zenone verso il 450 a.C., ove avrebbe conosciuto Socrate. Scrisse un
poema Sulla natura (Perì phýseōs) in due parti: la prima sulla verità, di cui ci è
restato un ampio frammento, la seconda sull’opinione, di cui restano pochi versi.
Fondamentale nella concezione di Parmenide è la questione dell’essere, posta
polemicamente nei confronti dei naturalisti e di Eraclito. Contro la teoria della
molteplicità dell’essere, che si fonda sulle opinioni ricavate dai sensi, Parmenide
afferma con estremo rigore l’impossibilità di pensare l’essere come movimento o
alterazione: ciò porterebbe necessariamente alla contraddizione di pensare l’essere
come insieme nonessere rispetto ad altro, e quindi alla vanificazione dello stesso
concetto di essere. Viceversa l’essere va colto con il pensiero, il logos, unico
strumento che consente di cogliere, attraverso l’immutabilità stessa della parola,
l’essere come identità compiuta, perfetta e immutabile, superando l’illusorietà
dell’opinione mutevole e contraddittoria. Parmenide raffigura l’essere come una
sfera sottratta alle determinazioni dello spazio e del tempo, indistinguibile in parti e
perfettamente omogenea. Per l’affermazione della assoluta superiorità della via del
pensiero rispetto a quella dell’opinione, e per la fiducia nella portata ontologica del
logos, Parmenide ha una importanza decisiva nella storia della filosofia greca in
quanto tra i primi ha identificato parola ed essenza, cogliendo nel giudizio logico lo
strumento della comprensione della razionalità del reale. Sotto questo profilo gli
viene altresì attribuita la scoperta di principi logici formali quali quello d’identità e
di non contraddizione, che saranno posti a fondamento delle elaborazioni razionaliste