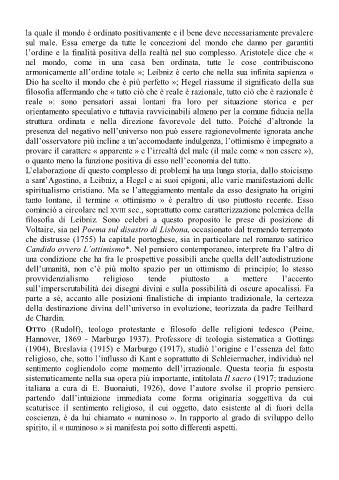Page 620 - Dizionario di Filosofia
P. 620
la quale il mondo è ordinato positivamente e il bene deve necessariamente prevalere
sul male. Essa emerge da tutte le concezioni del mondo che danno per garantiti
l’ordine e la finalità positiva della realtà nel suo complesso. Aristotele dice che «
nel mondo, come in una casa ben ordinata, tutte le cose contribuiscono
armonicamente all’ordine totale »; Leibniz è certo che nella sua infinita sapienza «
Dio ha scelto il mondo che è più perfetto »; Hegel riassume il significato della sua
filosofia affermando che « tutto ciò che è reale è razionale, tutto ciò che è razionale è
reale »: sono pensatori assai lontani fra loro per situazione storica e per
orientamento speculativo e tuttavia ravvicinabili almeno per la comune fiducia nella
struttura ordinata e nella direzione favorevole del tutto. Poiché d’altronde la
presenza del negativo nell’universo non può essere ragionevolmente ignorata anche
dall’osservatore più incline a un’accomodante indulgenza, l’ottimismo è impegnato a
provare il carattere « apparente » e l’irrealtà del male (il male come « non essere »),
o quanto meno la funzione positiva di esso nell’economia del tutto.
L’elaborazione di questo complesso di problemi ha una lunga storia, dallo stoicismo
a sant’Agostino, a Leibniz, a Hegel e ai suoi epigoni, alle varie manifestazioni dello
spiritualismo cristiano. Ma se l’atteggiamento mentale da esso designato ha origini
tanto lontane, il termine « ottimismo » è peraltro di uso piuttosto recente. Esso
cominciò a circolare nel XVIII sec., soprattutto come caratterizzazione polemica della
filosofia di Leibniz. Sono celebri a questo proposito le prese di posizione di
Voltaire, sia nel Poema sul disastro di Lisbona, occasionato dal tremendo terremoto
che distrusse (1755) la capitale portoghese, sia in particolare nel romanzo satirico
Candido ovvero L’ottimismo*. Nel pensiero contemporaneo, interprete fra l’altro di
una condizione che ha fra le prospettive possibili anche quella dell’autodistruzione
dell’umanità, non c’è più molto spazio per un ottimismo di principio; lo stesso
provvidenzialismo religioso tende piuttosto a mettere l’accento
sull’imperscrutabilità dei disegni divini e sulla possibilità di oscure apocalissi. Fa
parte a sé, accanto alle posizioni finalistiche di impianto tradizionale, la certezza
della destinazione divina dell’universo in evoluzione, teorizzata da padre Teilhard
de Chardin.
OTTO (Rudolf), teologo protestante e filosofo delle religioni tedesco (Peine,
Hannover, 1869 - Marburgo 1937). Professore di teologia sistematica a Gottinga
(1904), Breslavia (1915) e Marburgo (1917), studiò l’origine e l’essenza del fatto
religioso, che, sotto l’influsso di Kant e soprattutto di Schleiermacher, individuò nel
sentimento cogliendolo come momento dell’irrazionale. Questa teoria fu esposta
sistematicamente nella sua opera più importante, intitolata Il sacro (1917; traduzione
italiana a cura di E. Buonaiuti, 1926), dove l’autore svolse il proprio pensiero
partendo dall’intuizione immediata come forma originaria soggettiva da cui
scaturisce il sentimento religioso, il cui oggetto, dato esistente al di fuori della
coscienza, è da lui chiamato « numinoso ». In rapporto al grado di sviluppo dello
spirito, il « numinoso » si manifesta poi sotto differenti aspetti.