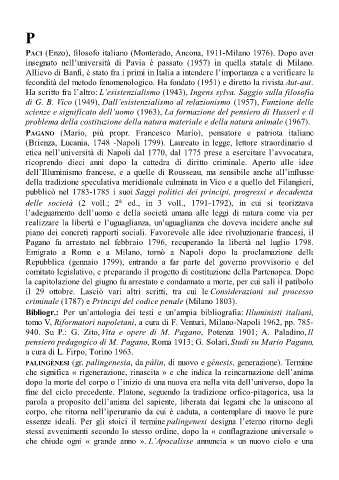Page 621 - Dizionario di Filosofia
P. 621
P
PACI (Enzo), filosofo italiano (Monterado, Ancona, 1911-Milano 1976). Dopo aver
insegnato nell’università di Pavia è passato (1957) in quella statale di Milano.
Allievo di Banfi, è stato fra i primi in Italia a intendere l’importanza e a verificare la
fecondità del metodo fenomenologico. Ha fondato (1951) e diretto la rivista Aut-aut.
Ha scritto fra l’altro: L’esistenzialismo (1943), Ingens sylva. Saggio sulla filosofia
di G. B. Vico (1949), Dall’esistenzialismo al relazionismo (1957), Funzione delle
scienze e significato dell’uomo (1963), La formazione del pensiero di Husserl e il
problema della costituzione della natura materiale e della natura animale (1967).
PAGANO (Mario, più propr. Francesco Mario), pensatore e patriota italiano
(Brienza, Lucania, 1748 -Napoli 1799). Laureato in legge, lettore straordinario di
etica nell’università di Napoli dal 1770, dal 1775 prese a esercitare l’avvocatura,
ricoprendo dieci anni dopo la cattedra di diritto criminale. Aperto alle idee
dell’Illuminismo francese, e a quelle di Rousseau, ma sensibile anche all’influsso
della tradizione speculativa meridionale culminata in Vico e a quello del Filangieri,
pubblicò nel 1783-1785 i suoi Saggi politici dei principi, progressi e decadenza
a
delle società (2 voll.; 2 ed., in 3 voll., 1791-1792), in cui si teorizzava
l’adeguamento dell’uomo e della società umana alle leggi di natura come via per
realizzare la libertà e l’uguaglianza, un’uguaglianza che doveva incidere anche sul
piano dei concreti rapporti sociali. Favorevole alle idee rivoluzionarie francesi, il
Pagano fu arrestato nel febbraio 1796, recuperando la libertà nel luglio 1798.
Emigrato a Roma e a Milano, tornò a Napoli dopo la proclamazione della
Repubblica (gennaio 1799), entrando a far parte del governo provvisorio e del
comitato legislativo, e preparando il progetto di costituzione della Partenopea. Dopo
la capitolazione del giugno fu arrestato e condannato a morte, per cui salì il patibolo
il 29 ottobre. Lasciò vari altri scritti, tra cui le Considerazioni sul processo
criminale (1787) e Principi del codice penale (Milano 1803).
Bibliogr.: Per un’antologia dei testi e un’ampia bibliografia: Illuministi italiani,
tomo V, Riformatori napoletani, a cura di F. Venturi, Milano-Napoli 1962, pp. 785-
940. Su P.: G. Zito, Vita e opere di M. Pagano, Potenza 1901; A. Paladino, Il
pensiero pedagogico di M. Pagano, Roma 1913; G. Solari, Studi su Mario Pagano,
a cura di L. Firpo, Torino 1963.
PALINGÈNESI (gr. palingenesia, da pálin, di nuovo e génesis, generazione). Termine
che significa « rigenerazione, rinascita » e che indica la reincarnazione dell’anima
dopo la morte del corpo o l’inizio di una nuova era nella vita dell’universo, dopo la
fine del ciclo precedente. Platone, seguendo la tradizione orfico-pitagorica, usa la
parola a proposito dell’anima del sapiente, liberata dai legami che la uniscono al
corpo, che ritorna nell’iperuranio da cui è caduta, a contemplare di nuovo le pure
essenze ideali. Per gli stoici il termine palingenesi designa l’eterno ritorno degli
stessi avvenimenti secondo lo stesso ordine, dopo la « conflagrazione universale »
che chiude ogni « grande anno ». L’Apocalisse annuncia « un nuovo cielo e una